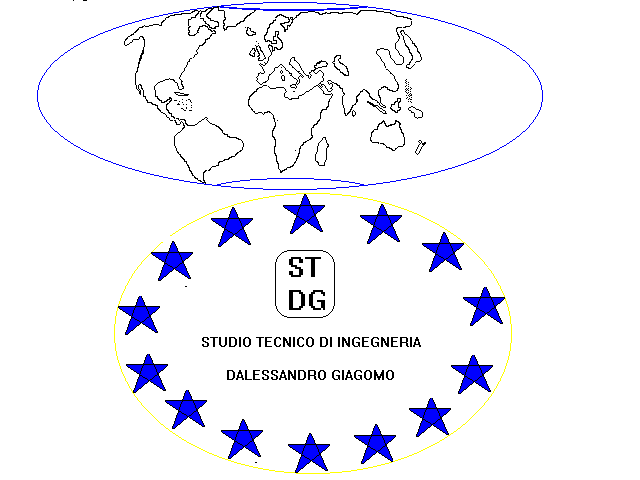|
CORRIERE della SERA
per l'articolo completo vai al sito Internet
http://www.corriere.it
2009-12-12
il 12 dicembre 1969 una bomba provocò 17 vittime
Piazza Fontana, fischi e contestazioni
per Moratti, Podestà e Formigoni
Il sindaco di Milano fischiata durante il discorso di commemorazione della strage alla Bna
*
NOTIZIE CORRELATE
*
Ricordare piazza Fontana Una strage ancora senza colpevoli (11 dicembre 2009)
L'attentato del 12 dicembre 1969
L'attentato del 12 dicembre 1969
MILANO - Fischi e contestazioni. Dopo aver deposto le corone davanti alla banca Nazionale dell'Agricoltura, il sindaco di Milano Letizia Moratti, il presidente della Provincia Guido Podestà e il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni sono stati sonoramente fischiati non appena sono saliti sul palco, al termine del corteo promosso dalle istituzioni per il quarantennale della strage di Piazza Fontana a Milano. Da più parti si sono levate grida come "Vergogna", "Strage di Stato", "Fascisti!". Uno dei familiari delle vittime, Paolo Silva, ha cercato inutilmente di zittire la folla: "Un po' di rispetto, per favore, state zitti".
MORATTI - "Capisco chi protesta, capisco i fischi, perchè chiedono giustizia, una giustizia che è stata negata per 40 anni" ha detto poi Letizia Moratti. "Lo dico con umiltà - ha dichiarato ancora il sindaco di Milano - non ci possono essere parole di consolazione per le famiglie, ma credo che la giustizia possa nascere solo da una coscienza collettiva". Nel suo intervento la Moratti ha ricordato che il Comune realizzerà una casa della memoria, dove troveranno posto tutte le associazioni dei familiari delle vittime del terrorismo e dello stragismo e che sarà un centro di documentazione sugli anni più bui della storia della Repubblica.
IL CORTEO - Il discorso della Moratti è arrivato dopo che si era svolto il corteo cittadino, quello ufficiale. Un secondo corteo, organizzato dalle sinistre, si era svolto separatamente. Dopo il concentramento in piazza della Scala, la manifestazione era partita alla volta della piazza dove, quarant'anni fa esplose una bomba collocata nella Banca Nazionale dell'Agricoltura provocando 17 morti e 84 feriti. Alla testa del corteo, molto partecipato, c'erano i familiari delle vittime, che esponevano uno striscione "Famiglie vittime strage di piazza Fontana". Dietro c'erano numerosissimi i gonfaloni che rappresentavano le città che partecipavano alla commemorazione. In fondo al corteo sventolavano invece numerose bandiere di partito, quelle del Pd, del Partito socialista e molte bandiere rosse.
SCONTRI - Alla fine del corteo ci sono stati però anche momenti di tensione, tra alcuni manifestanti dell'area antagonista, appartenenti al secondo corteo, quello delle sinistre e la polizia, schierata dietro alla transenne, con lancio di sassi e petardi al margine di Piazza Fontana. La polizia e i carabinieri in tenuta antisommossa hanno cercato di contenere il tentativo di sfondamento di oltre un centinaio di giovani dell'area antagonista. La polizia ha reagito a colpi di manganello. Nessun manifestante ha superato la transenne.
TORNA LA CALMA - Alla fine però è tornata la calma. Sul palco della storica piazza, sono arrivati i manifestanti che hanno superato il cordone delle forze dell'ordine, sventolando bandiere rosse e cantando "Bella Ciao". Una parte delle transenne, infatti, erano state tolte, subito dopo il termine della manifestazione ufficiale, quella delle autorità cittadine, e attraverso questo varco si sono riversate centinaia di manifestanti del secondo corteo. che ora stanno dando vita a una sorta di festa in piazza.
12 dicembre 2009
|
REPUBBLICA
per l'articolo completo vai al sito Internet
http://www.repubblica.it/
2009-12-12

Commemorazione della strage nel giorno del 40esimo anniversario
Contestati il sindaco Moratti, il presidente della Provincia Podestà e Formigoni
Piazza Fontana, a Milano due cortei
Napolitano: "Continuare a cercare verità"
Piazza Fontana, a Milano due cortei Napolitano: "Continuare a cercare verità"
L'interno della Banca dell'Agricoltura, devastato dalla bomba
MILANO - Continuare a cercare la verità. E' l'invito che il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha rivolto ai familiari delle vittime di Piazza Fontana in occasione del 40esimo anniversario della strage. E durante i due cortei a Milano non sono mancate le tensioni. Contestati con fischi e urla il sindaco di Milano Letizia Moratti, il presidente della Provincia Guido Podestà e il presidente della Regione Roberto Formigoni. I manifestanti dei centri sociali hanno cercato di sfondare i cordoni di polizia per entrare in piazza Fontana; lanci di petardi e fumogeni, abbattute alcune transenne.
Il monito di Napolitano. Una ricerca della verità costante, che possa condurre a dei risultati. Questo il senso dell'intervento del capo dello Stato, un minito a "continuare a cercare perché si possa recuperare qualsiasi frammento di verità rimasto nascosto. Spero che questa vostra ricerca, a cui debbono collaborare tutte le istituzioni, possa condurre a dei risultati. E' essenziale che quello che avete vissuto, quello che è accaduto nel nostro Paese - ha detto Napolitano - diventi parte di una consapevolezza storica, soprattutto per le nuove generazioni".
I cortei. Per commemorare i 40 anni dalla strage, a Milano sono stati organizzati due cortei. Il primo è stato aperto da una delegazione dei familiari delle vittime e dai gonfaloni di numerose città, primo tra tutti quello di Milano dietro il quale ha sfilato anche il sindaco Moratti, che durante l'intervento è stata oggetto di una pesante contestazione: dal pubblico sono arrivati fischi e parecchi "Vergogna!". "Capisco chi protesta, capisco i fischi - ha replicato il primo cittadino - perché chiedono giustizia, una giustizia che è stata negata per quarant'anni". Il secondo corteo è quello organizzato da Prc, Comunisti italiani e altre organizzazioni della sinistra e anarchiche. A distanza ravvicinata la conclusione delle due manifestazioni: quella ufficiale - la prima - in piazza Fontana, mentre quello delle sinistre in piazza Santo Stefano, nei pressi dell'Università Statale e a poche decine di metri dal luogo della strage del 1969.
(12 dicembre 2009
Piazza Fontana, il giorno della strage
Il 12 dicembre 1969, alle 16.37 una bomba esplode nella Banca Nazionale dell'Agricoltura: 14 i morti, 87 i feriti; tre non sopravviveranno. Nel giorno dei funerali si diffonde la notizia che uno dei fermati, l'anarchico Giuseppe Pinelli, è morto durante gli interrogatori. Ci vorranno 40 anni per iscrivere nelle parole del presidente Napolitano il suo nome come diciottesima vittima della strage, che introdusse la lunga stagione del terrorismo e dei misteri d'Italia
La prima vittima della "strategia della tensione"
Il 18 novembre 1969, nei violenti scontri davanti al Teatro Lirico nel giorno dello sciopero generale per la casa, muore l'agente Antonio Annarumma
di Filippo Azimonti
Percorrere via Larga il 18 novembre cercando le tracce di quello che avvenne esattamente quarant’anni fa attorno a mezzogiorno: come allora ci sono i ponteggi di un cantiere ma nessuna targa ricorda Antonio Annarumma, 22 anni, agente della Celere, arrivato due mesi prima da Monteforte Irpino per trovare la morte a pochi metri dal Teatro Lirico.
Era un martedì. Apollo 12 era atterrato sulla Luna, Conrad e Bean avevano mosso i primi passi nell’Oceano delle tempeste in un’a vventura annunciata su tutte le prime pagine accanto a quella dello sciopero generale per la casa. Tutta Italia si era fermata, 19 milioni di lavoratori per l’Unità (10 per il Corriere) avevano incrociato le braccia.
Quel giorno a Milano i sindacati avevano organizzato un’assemblea al Teatro Lirico. In via Larga sfilava il corteo dell’Unione dei marxisti leninisti. L’Università Statale era presidiata dal Movimento studentesco. E la polizia era schierata in forze in tutta la zona.
Bastava poco perché scoccasse una scintilla. E accadde: una camionetta della polizia in manovra sfiora un gruppo di manifestanti, che reagiscono violentemente e danno il via a una catena di eventi che avranno un tragico epilogo.
I confronti sempre più duri tra polizia, studenti e operai si erano ripetuti lungo l’intero corso dell’anno in città. E nel Paese già si compilava il triste elenco dei morti nelle manifestazioni di piazza: a Battipaglia, il 9 aprile, mentre protestavano per la chiusura dello stabilimento dei tabacchi erano stati colpiti da proiettili "vaganti" Carmine Citro, 19 anni, e Teresa Ricciardi, 30; a Pisa, il 27 ottobre, Cesare Pardini, 22 anni, era stato colpito alla testa da un candelotto lacrimogeno. Ad ogni annuncio di morte un brivido percorreva le piazze, si contavano le proteste e poi i feriti e gli arrestati.
Ma a Milano si stava preparando qualcosa di completamente diverso. Lo spiegherà sul Giorno Enzo Forcella che, condannando le violenze di quella mattina, annotava che "lo sciopero generale costituisce un’arma rischiosa di cui non si può mai prevedere con esattezza la portata". Ma, soprattutto, segnalava che "questa volta il morto non appartiene alle categorie dei braccianti, degli operai, degli studenti contestatori" mentre Giorgio Bocca raccontava dalla Fiat "le voci dure di Torino".
Il clima era definitivamente cambiato. Anche nelle reazioni. Il presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, parla di "barbaro assassinio" il ministro dell’Interno Franco Restivo di "aggressione all’autorità dello Stato" e nelle ricostruzioni di quanto avvenuto davanti al Lirico compare un giovane in maglione marrone che colpisce con una sbarra di ferro l’agente alla guida del gippone. Quanto basta per additare all’opinione pubblica il "furore di gruppi teppistici". E le notizie quel giorno arrivano solo dai giornali radio e dai telegiornali; i quotidiani sono in sciopero, e quando, il 20 novembre, torneranno in edicola, la versione dei fatti resterà quella ufficiale anche se l’Unità , l’Avanti!, Paese Sera parlano di "incidenti provocati da una brutale e preordinata aggressione poliziesca". E Cgil Cisl Uil denunciano le responsabilità della Ps.
Quel giovane in maglione citato in tutte le cronache non si troverà mai, non tra i 19 arrestati, non tra le decine di feriti. Le foto di quel giorno e un filmato di una troupe francese, mai acquisito agli atti del processo e poi scomparso, raccontano di un gippone che sbanda e si scontra con un altro mezzo militare dopo aver zigzagato tra i tubi Innocenti usati dai manifestanti per erigere improvvisate barricate e bloccare le cariche. Il che non esclude che il giovane agente abbia perso il controllo per un colpo ricevuto. Ma di questo non si parlerà al processo che si concluderà senza individuare i colpevoli, come sarebbe accaduto molte altre volte in un intreccio di silenzi e omissioni che inaugura la stagione dei misteri. E fa di Antonio Annarumma la prima vittima della "strategia della tensione".
Ai suoi funerali dall’imponente corteo che ne accompagnava la bara, si levarono anche tante braccia tese nel saluto fascista mentre si consumava l’aggressione a Mario Capanna, leader del Movimento studentesco andato a portare la propria solidarietà personale e sottratto al linciaggio da un giovane commissario, Luigi Calabresi.
Ad Antonio Annarumma Milano ha intitolato, un giardino, la caserma del III reparto Mobile e una medaglia al valor civile, nel maggio del 2009. Ma una targa per lui ancora non c’è.
Percorrendo via Larga dal lato dei numeri dispari all’altezza di via Bergamini una lapide c’è. È per Saverio Saltarelli : "Ucciso il 12 dicembre 1970 a soli 23 anni, mentre lottava contro il fascismo per la democrazia e il socialismo". Le cronache raccontano che fu colpito alla testa da un lacrimogeno sparato ad altezza d’uomo. E gli anni di piombo erano più vicini.
(18 novembre 2009)
A parlare per primo di "Autunno caldo" fu il leader socialista Francesco De Martino, intervenendo in aula ai primi di settembre del 1969. Fiat e Pirelli avevano appena fatto scattare la sospensione di migliaia di operai dei loro stabilimenti per contrastare l'ondata di scioperi per il rinnovo dei contratti di chimici e metalmeccanici. Erano le prime fasi di una mobilitazione che avrebbe coinvolto cinque milioni di lavoratori che rivendicavano più soldi, più dignità e più diritti e che trovavano per la prima volta al loro fianco studenti, impiegati, e ampi settori dei ceti borghesi e intellettuali. Una scossa che avrebbe messo a dura prova un Paese che ancora coltivava il sogno del boom senza essersi accorto di quel che era cambiato attorno alle catene di montaggio. L'’autunno caldo, per la gran parte degli imprenditori, oggi, "fu una ventata di follia, interrottasi solo con la marcia dei quarantamila a Torino", oppure "una spinta epocale a cambiare la società" come raccontano gli storici del movimento operaio. Per la cronaca, migliaia di operai, lavoratori, impiegati, studenti in piazza, quelli che vediamo negli scatti di un foto-reporter di allora, Giancarlo De Bellis che fissò i momenti della protesta, ma anche quelli della vita di tutti i giorni in una Milano che è difficile riconoscere nei volti ma anche nei luoghi
L'Italia del 1969
Il Paese è democristiano, un monocolore dalla vita molto travagliata esposto ai ricatti dei moderati liberali e repubblicani e alle pressioni degli ex alleati socialisti, Milano è governata da Aldo Aniasi. Comunismo e fascismo non sono ideologie antiquarie ma passioni che portano in piazza e allo scontro. Una mappa del potere tutta da ricostruire alla luce degli avvenimenti che punteggiano i mesi dell'autunno caldo | LA CRONOLOGIA
http://temi.repubblica.it/espresso-piazza-fontana/
La strage riaperta
di Paolo Biondani
Approfondimenti
L'INTERVISTA 'La mia verità': colloquio con l'ex capo del Sid Gianadelio Maletti
GUARDA Il video
Quarant'anni dopo la grande strage impunita, c'è una nuova pista nera che porta in piazza Fontana. Un mistero del Sid custodito dal condannato più eccellente, il generale Gianadelio Maletti, che dal suo rifugio dorato in Sudafrica ora comincia a parlarne, per la prima volta (in questa intervista) con meno reticenze del passato.
È la storia di un neonazista giovanissimo, che sparisce dall'Italia dopo i 17 morti del 12 dicembre 1969, ma ancor prima che il suo maestro Franco Freda venga arrestato e condannato per i 21 attentati preparatori di quella strage che ha cambiato la storia d'Italia.
Questo strano fantasma che sparisce senza essere ricercato si chiama Ivano Toniolo. Il suo ruolo è tanto inquietante da aver convinto i magistrati milanesi a riaprire a sorpresa gli interrogatori sulle bombe nere. Figlio di un generale che fu gerarca fascista, Toniolo nel '69 aveva meno di vent'anni, eppure era già inserito nel nocciolo duro dei neonazisti del gruppo Freda. Di lui ha parlato un testimone d'eccezione, Gianni Casalini, che si è autoaccusato di avere aiutato Toniolo a mettere due bombe sui treni a Milano, quattro mesi prima della strage.
Segretario del Msi di Padova dal '60 al '63, Casalini era entrato in Ordine Nuovo con l'intero club di "disintegratori del sistema" che dal '68 si riunivano nella libreria di Freda. Nell'ottobre del '72 è diventato una fonte dei carabinieri che lavoravano per il Sid, il servizio segreto che, invece di aiutare la giustizia, distruggeva le prove e faceva scappare i ricercati.
Nel settembre 2008 Casalini ha scritto al giudice Guido Salvini e in dicembre ha accettato di farsi interrogare dal pm Massimo Meroni, i due magistrati che negli anni '90 avevano inutilmente ritentato di ottenere le prime condanne per piazza Fontana.
L'interrogatorio è ancora segreto, ma il 10 luglio Casalini ne ha dovuto ripetere la parte centrale al processo per la strage di Brescia del 28 maggio 1974, un'altra bomba nera ancora senza colpevoli.
"Nell'agosto 1969, un pomeriggio, entrai nella libreria Ezzelino di Freda, dove c'era Ivano Toniolo. Era molto più giovane di me, mi pare fosse all'ultimo anno delle superiori, ma era già uno del gruppo. Toniolo mi disse: "Dopodomani fatti trovare in stazione che andiamo a Milano a fare due botti". (...) Prendemmo il treno in prima classe. Lui aveva due ordigni in una cartella di quelle senza manico, io me n'ero portata un'altra come alibi. (...) Toniolo andò due volte a innescarle nelle toilette a pagamento. La prima la mise su un vagone straniero, avvolta in carta da regalo. Poi scendemmo e lui andò a innescare la seconda. Lo trovai che usciva dal treno. Quando sentii l'altoparlante della stazione chiamare un brigadiere, dissi: "L'hanno trovato, qua va male, filiamo". Per la fretta prendemmo proprio quel treno, che a Vicenza si fermò un'ora, per lo scoppio. Quella sera pensavo che fossimo solo io e lui, ma al mattino, alla radio, seppi che erano scoppiate dieci bombe in tutta Italia".
Casalini è sempre rimasto libero e non ha alcun interesse ad autoaccusarsi. Anzi, continua a rivendicare gli attentati ai treni: "Non mi sono mai pentito: nel '69 c'era la contestazione giovanile...".
La strage riaperta
di Paolo Biondani
Approfondimenti
L'INTERVISTA 'La mia verità': colloquio con l'ex capo del Sid Gianadelio Maletti
GUARDA Il video
Per misurare il peso della sua confessione, basta ricordare che la verità giudiziaria si è fermata proprio lì: Franco Freda e il suo complice Giovanni Ventura sono stati condannati definitivamente per la serie nera di attentati iniziati nell'aprile '69 e culminati proprio con le bombe sui treni del 7-8 agosto. Per la strage del 12 dicembre, invece, entrambi furono assolti in appello a Catanzaro, insieme all'agente del Sid Guido Giannettini.
Il processo-bis degli anni '90 ha però dichiarato "storicamente certa la responsabilità di Freda e Ventura anche per piazza Fontana", grazie a nuove prove (come la testimonanza-choc del loro elettricista-artificiere) che però non si possono più usare contro di loro, per il divieto di giudicarli due volte per lo stesso fatto.
Dopo la strage, nessuno ha più rivisto Toniolo in Italia. Casalini ricorda che "Marco Pozzan, quando rientrò dalla latitanza, disse che lo aveva visto in Spagna, ma che Toniolo si era voltato dall'altra parte". Segnalato anche in Grecia, oggi risulta "residente in Angola".
Pozzan, per inciso, è uno dei ricercati che scapparono all'estero con i passaporti falsi del Sid. Una fuga gestita da due ufficiali poi condannati per favoreggiamento: Gianadelio Maletti e il capitano Antonio Labruna, entrambi piduisti. Ma a beneficiare di un altro depistaggio, che si scopre solo ora, fu proprio Ivano Toniolo. Casalini, sotto giuramento, ha testimoniato che le bombe sui treni lui le confessò "già nell'ottobre 1972", cioè "fin dall'inizio" delle sue confidenze al Sid, che lo chiamava "Fonte Turco". Il primo documento che ne parla è però un "appunto a Maletti" datato 5 giugno 1975, sequestrato a casa del generale quando questi scappò in Sudafrica. Quella velina avvertiva: "Casalini si vuole scaricare la coscienza. Ha cominciato con l'ammettere che ha partecipato agli attentati ai treni del '69". Mezza Italia era ancora convinta che tutte le bombe tra aprile e dicembre le avessero messe gli anarchici innocenti Valpreda e Pinelli, eppure Maletti, senza mai informare i giudici, ordinava: "Chiudere la fonte Turco". Dunque Casalini aveva smesso nel '75 di informare il Sid sui terroristi di destra? Nossignori. "Io ho continuato a parlare col Sid fino al '79-80. Ma i miei carabinieri mi dicevano che Roma non voleva sentire. E poi Maletti fece sparire i miei incartamenti dal '75 in poi". Il generale del Sid, tuttora ricercato, ora lancia un segnale ai giudici che lo hanno convocato a Brescia: "Attendo un salvacondotto per venire anch'io a testimoniare sulle stragi"..
Piazza Fontana, la mia verità
di Nicola Palma, Andrea Sceresini e Maria Elena Scandaliato
L'esplosivo per l'attentato fornito dagli americani. Il ruolo di Andreotti e di un ministro. Un neonazista implicato e finora sconosciuto. Parla l'ex capo del Sid Gianadelio Maletti
Approfondimenti
Piazza Fontana, quarant'anni di misteri
Gianadelio Maletti
Illovo, nel cuore bianco di Johannesburg. Un grande appartamento, arredato all'antica. Il portiere di colore, giù nell'atrio, si leva il cappello e lo saluta con un inchino: "Good morning, my general". Gianadelio Maletti, 88 anni, è l'ex capo del controspionaggio del Sid. "Un esiliato politico ", dice lui.
È scappato dall'Italia nel 1980, per sfuggire all'arresto e alla condanna definitiva per i depistaggi di piazza Fontana. Ora dal Sudafrica, dove in un weekend di metà novembre si è reso disponibile per questa intervista, lancia un segnale preciso ai giudici che lo hanno convocato a Brescia per il processo in corso per la strage di piazza della Loggia: "Attendo un salvacondotto per poter venire anch'io a testimoniare sulle stragi".
Il generale Maletti racconta particolari inediti sulla pista nera e sulle coperture politiche. Ma, soprattutto, conferma il ruolo di un protagonista tutto nuovo della strategia del terrore e cioè Ivano Toniolo, il neonazista sparito nel nulla (sarebbe ora in Angola), la cui figura è tanto inquietante da aver convinto i magistrati milanesi a riaprire a sorpresa gli interrogatori sulle bombe nere.
Di Toniolo ha parlato la prima volta Gianni Casalini, il militante di Ordine Nuovo reclutato nel 1972 dal Sid come "Fonte Turco" e poi bruciato dallo stesso Maletti. Testimoniando al processo di Brescia, Casalini si è autoaccusato di aver aiutato proprio Toniolo a mettere due bombe sui treni a Milano, quattro mesi prima di Piazza Fontana.
Generale, è vero che una parte dell'esplosivo della strage arrivò dalla Germania?
"Da un deposito militare americano in Germania. Entrò in Italia dal Brennero, a bordo di uno o più Tir. Fu scaricato a Padova, dove venne affidato agli ordinovisti locali".
Di che esplosivo si trattava?
"Ricordo l'informativa: parlava di trinitrotoluene. Ovvero, tritolo".
Era una notizia attribuita dal Sid alla "Fonte Turco", cioè Casalini?
"Mi pare proprio di sì".
Eppure, nel giugno 1975, lei ordinò di "chiudere la Fonte Turco". Forse perché poteva parlare di Giannettini, suo informatore diretto, e coinvolgere il Sid?
"Guardate, non ricordo. Forse c'erano motivi giudiziari che consigliavano di chiudere il contatto. Non ricordo".
Casalini era un militante del gruppo di Freda e Ventura e partecipò agli attentati sui treni dell'8 e 9 agosto '69. Lei lo sapeva, perché non informò la magistratura?
"Scusate, ma cosa siete voi? Giudici o giornalisti? Partecipare può anche voler dire fare da palo. Può aver portato l'esplosivo, ma senza piazzarlo personalmente sui treni. È tutto".
Generale, lei parla di un deposito americano in Germania. Gli Usa volevano la strage?
"No, io non credo. In piazza Fontana non doveva morire nessuno: la bomba doveva avere un effetto psicologico, politico. Gli americani fornivano mezzi ed esplosivo, ma il lavoro lo lasciavano fare agli indigeni. C'era un laissez-faire, un indirizzo generale, poi messo in pratica da gruppi italiani o internazionali. Se ne occupavano i servizi segreti, ma non solo la Cia".
E da chi partiva questa strategia?
"Nixon ne era a conoscenza. Era un uomo d'azione: molto spregiudicato e molto anti- sovietico. Tutto ciò andò avanti fino al tramonto di Nixon. Fino alla strage di Brescia, insomma".
Nixon sapeva anche del golpe Borghese?
"Direi di sì. C'era un filo diretto, in questo senso. Ma non bisogna stupirsene. L'Italia stava a Washington, in quegli anni, come l'Austria di Dolfuss stava a Mussolini. Era stato il servizio americano, ad esempio, a finanziare la costruzione della base militare di capo Marrargiu, dove si addestravano i gladiatori. Questo era il clima".
E in Italia chi sapeva?
"Io sono convinto di questo: della strategia americana, sia il capo dello Stato, il presidente Saragat, sia Andreotti sapevano. Non direi che avessero un coinvolgimento diretto.
Piazza Fontana, la mia verità
di Nicola Palma, Andrea Sceresini e Maria Elena Scandaliato
Approfondimenti
Piazza Fontana, quarant'anni di misteri
Andreotti, probabilmente, ha lasciato un po' fatalisticamente che le cose prendessero il loro corso, non immaginando la strage: avrà pensato a una bomba che può rompere un po' di vetri. Fece così anche un anno dopo, con il golpe Borghese".
Generale, lei conosceva molto bene Mino Pecorelli, il giornalista di "Op" ucciso nel 1979. Andreotti è stato assolto senza rinvio dalla Cassazione. Lei che ne pensa?
"Posso dire questo. Pecorelli venne da me tre o quattro giorni prima di essere ucciso. Era molto scosso, si sentiva minacciato. Quando uscì di casa si accomiatò così: "Arrivederci... forse". Ebbene, in quell'occasione mi disse che Licio Gelli, pochi giorni prima, gli aveva offerto tre milioni di lire per ritirare dal mercato l'ultimo numero di "Op", "Tutti gli assegni del presidente". Gli chiesi: "Per conto di chi lo ha fatto?" E lui: "Per conto di Andreotti"".
Lei parla di rapporti strettissimi tra Andreotti e Gelli. Ma il senatore a vita ha sempre sostenuto che si conoscevano appena...
"Andreotti conosceva molto bene il capo della P2. Gelli stesso mi diceva che si vedevano di frequente e che parlavano di politica. E io credevo a Gelli, un uomo di potere che non aveva bisogno di vantare contatti".
Sul golpe Borghese, lei dichiarò al giudice Casson che il parlamentare democristiano Gioia aveva tentato di coinvolgere elementi mafiosi.
"Sì, ricordo bene il dossier su Gioia. Fu bruciato nel 1974".
Bruciato? E perché?
"Era l'agosto del 1974. L'ordine arrivò dal governo. Venne anche una commissione, di cui faceva parte l'onorevole Guadalupi. Furono distrutti oltre 20 mila dossier, tutto il materiale sugli elementi indagati dal Sid nel corso degli anni: le cosiddette malefatte del Sid. Caricammo i faldoni su autocarri e li portammo all'inceneritore di Fiumicino. C'ero io, c'era il colonnello Viezzer e c'era qualche parlamentare".
Erano fascicoli personali?
"Sì, anche cose di poco conto: storie di cardinali che andavano a letto con la perpetua... C'era anche questo".
Il Sid, negli stessi mesi, stava finendo nel mirino della magistratura. Il 31 ottobre fu arrestato il generale Miceli. È un caso?
"Io so solo questo: il rogo di Fiumicino è stata un'opera di cautelazione contro certe cose che avrebbero potuto emergere. Non ho letto i dossier, non so altro".
Dopo 40 anni, lei sa i nomi dei responsabili della strage di piazza Fontana?
"Io conosco dei nomi, ma non ho prove, e non li faccio".
Il nome di un nuovo sospettato, allora, glielo facciamo noi: Ivano Toniolo.
"Può darsi. Mi lasci dire: può darsi. Ma ci sono altre persone, oltre a Toniolo. Alcuni mai indagati. Sto parlando di chi partecipò attivamente all'organizzazione dell'iniziativa".
Quando sapremo tutta la verità?
"Quando morirà qualcuno. E non parlo del sottoscritto. Qualcuno che ha pubblicato recentemente delle memorie di successo. E che su certi punti, però, ha elegantemente sorvolato ".
Solo lui può dirci la verità?
"No, non solo lui. Ci sono anche altri, nel mondo politico. Me ne viene in mente uno, che faceva il ministro. Non in questo governo, non in quello precedente: in quello prima ancora. Ma non parlano, è inutile: non parlano".
Perché proprio la strage di piazza Fontana è ancora un mistero? Il caso Moro, ad esempio, è stato risolto.
"Ah, il caso Moro. Vedete, gli uomini delle Brigate rosse sono stati arrestati, è vero. Ma è questa la soluzione del caso Moro? I brigatisti hanno agito per conto loro, o per conto terzi? La stessa cosa vale per piazza Fontana. Forse, col tempo si saprà...".
Intervista prodotta da G.Pedote e F.Virga per la Mir Cinematografica.
1 2 3
Pagina 3 di 3
(10 Dicembre 2009)
Chi era Giuseppe Pinelli
Ferroviere anarchico, aveva partecipato alla Resistenza. Morì in circostanze poco chiare durante un fermo di polizia, tre giorni dopo la strage di piazza Fontana, avvenuta il 12 dicembre 1969
Giuseppe Pinelli era un ferroviere anarchico milanese, che da ragazzo aveva partecipato alla Resistenza. Negli Anni Sessanta, svolgeva attività politica con gli anarchici milanesi, in particolare con il Circolo Ponte della Ghisolfa, luogo di animazione storico dell'anarchismo in città. Dopo lo scoppio di una bomba in una sede della Banca nazionale dell'Agricoltura nel centro di Milano (Strage di piazza Fontana, 12 dicembre 1969), Pinelli venne fermato insieme ad altri anarchici milanesi. La Questura di Milano riteneva infatti che l'attentato potesse avere una matrice anarchica, e aveva accusato in particolare Pietro Valpreda (che poi verrà assolto).
Il 15 dicembre, tre giorni dopo la strage, Pinelli si trovava negli uffici della questura milanese, al quarto piano di via Fatebenefratelli, dove si era recato da solo - con il proprio motorino - convocato dal giovane commissario Luigi Calabresi, che Pinelli già conosceva. Nell'ufficio di Luigi Calabresi, Pinelli fu interrogato per ore dallo stesso commissario e da altri ufficiali, tra cui Antonino Allegra, responsabile dell'ufficio politico della questura.
Il questore di Milano era Marcello Guida, già direttore del confino politico cui venivano condannati gli antifascisti a Ventotene. Nella serata del 15 dicembre, attorno a mezzanotte, il corpo di Pinelli precipitò dalla finestra e si schiantò nel cortile della questura.
Ma quale fu la reale dinamica di quella morte? Cadde? Fu buttato? si suicidò?
In una prima fase la polizia riferì che Pinelli si era suicidato, gettandosi dalla finestra. Più avanti cambiò versione, parlando di una caduta accidentale.
Successivamente a una serie di inchieste e dopo la riesumazione del cadavere, la magistratura stabilì che Pinelli era caduto per un "malore attivo", cioè si era avvicinato alla finestra e a seguito di un malore aveva perso l'equilibrio ed era precipitato.
Una violenta campagna di stampa dell'estrema sinistra, e in particolare di "Lotta Continua", indicò il commissario Luigi Calabresi come assassino di Pinelli.
Il 15 maggio 1972 Luigi Calabresi venne ucciso a Milano.
Nel luglio del 1988 la Procura di Milano arrestò quattro ex membri di Lotta Continua: Adriano Sofri, Ovidio Bompressi, Giorgio Pietrostefani e Leonardo Marino.
L?accusa si basava sulle parole di Marino, che sosteneva di aver svolto la funzione di autista in quell'omicidio, mentre Bompressi sarebbe stato l'esecutore materiale, Sofri e Pietrostefani (che di Lotta Continua erano i dirigenti) i mandanti.
Dopo diversi processi, nel 2000, la Cassazione ha reso definitiva l'ultima sentenza della Corte d'Assise di Appello che aveva condannato Bompressi, Pietrostefani e Sofri a 22 anni (per Marino 11 anni, con prescrizione).
Attualmente Adriano Sofri si trova in detenzione domiciliare per motivi di salute. Bompressi è stato graziato da Napolitano. Pietrostefani vive in Francia ed è ufficialmente latitante.
(15 Gennaio 2009)
15 gennaio 2009 - L'intervista
Pinelli me l’hanno ucciso mille volte
di Chiara Valentini
La tragedia. Le 'bugie dei processi'. Le difficoltà della sua famiglia. Parla la vedova dell'anarchico Colloquio con Licia Pinelli
Non è facile avvicinare Licia Rognini. Da quella notte di quasi quarant'anni fa, quando suo marito, il ferroviere anarchico Pino Pinelli, era volato giù dal quarto piano della Questura di Milano, ha sempre scelto di parlare pochissimo. Ma il rumore che ancor prima di arrivare in libreria ha provocato il libro di Adriano Sofri anticipato da 'L'espresso' ('La notte che Pinelli', Sellerio) l'ha convinta. Di quelle vicende drammatiche che hanno cambiato per sempre la sua vita d'altra parte Licia Pinelli non ha mai smesso di occuparsi. Attiva e lucidissima a 81 anni compiuti (ma ne dimostra dieci di meno), nella sua casa dietro Porta Romana a Milano sta scannerizzando la montagna degli atti dei vari procedimenti giudiziari "perché la carta cominciava a disfarsi e invece la memoria deve restare". Ma va anche a scuola di yoga, si occupa dei quattro nipoti che ha avuto dalle figlie Claudia e Silvia, bambine di 8 e 9 anni al momento della tragedia. E con un'amica scrive inaspettatamente piccoli trattati di astrologia, quasi una parentesi nella severità della sua vita.
Signora Licia, Sofri ha ricostruito puntigliosamente la vicenda di suo marito sulle carte giudiziarie spiegando, queste sono le sue parole, "è il debito che pago alla memoria di Pinelli". Pensa che ce ne fosse bisogno?
"Molto probabilmente è un lavoro utile. Tanti, da Camilla Cederna a Marcello Del Bosco ad altri l'avevano fatto negli anni '70. Io stessa ne avevo parlato in un libro scritto nell'82 con Piero Scaramucci che è da tempo introvabile. Ma rivedere tutto quel che è successo con gli occhi di oggi, mostrando le contraddizioni dei vari processi, può servire. La morte di mio marito, a 40 anni di distanza, è una ferita aperta, un'ingiustizia che deve essere riparata".
Crede che sia possibile?
"Ancora oggi mi è difficile parlarne. Quel che ho vissuto mi ha fatto diventare dura, diffidente. Non sopporto i bugiardi, gli ipocriti, le versioni di comodo. Ma nonostante tutto spero che qualche margine ci sia ancora. Sono troppe le bugie di quei processi, le contraddizioni fra Caizzi, il primo giudice che archivia il fatto come morte accidentale, il giudice Amati che parla di suicidio e D'Ambrosio che conclude per il 'malore attivo'. Non posso credere che questa tragedia sia sepolta senza una verità".
Pensa che Sofri, che sta scontando una condanna come mandante dell'omicidio del commissario Calabresi, sia la persona più adatta?
"Non ho mai creduto alla colpevolezza di Sofri e dei suoi compagni, neanche come ispiratori di quel delitto. Sofri non l'ho mai conosciuto di persona, ma anni fa ho risposto a una sua lettera arrivata dal carcere appunto dicendogli questo. Non so neanche se poi gliel'avevano recapitata".
Alla fine del suo libro è Sofri stesso, che pure si è sempre dichiarato innocente, ad assumersi nuovamente una corresponsabilità morale di quell'omicidio per la campagna di Lotta continua contro il commissario.
"È mia convinzione che i responsabili vadano cercati altrove. So che è un'opinione poco condivisa, ma credo che Calabresi sia stato ammazzato perché non potesse più parlare, come tanti altri che avevano avuto a che fare con la strage di piazza Fontana".
Qualcuno ha osservato che dopo quarant'anni potrebbe trovare una pacificazione con la famiglia Calabresi, incontrare quell'altra vedova.
"Potrebbe anche darsi".
Che cosa ha provato quando ha saputo della morte del commissario?
"Per me era stato come se mettessero una pietra sopra la ricerca della verità. Ma a caldo avevo avuto anche una reazione emotiva, smarrimento e paura per me e le mie figlie. Non ci potevo credere, non volevo affrontare un'altra tragedia, essere bersagliata di nuovo dalle telefonate, dalle lettere anonime. Pensi che proprio quel giorno, il 17 maggio 1972, a Milano si doveva presentare a Palazzo Reale un quadro di Enzo Baj con la caduta di mio marito dalla finestra della Questura. Ovviamente non se ne fece più niente".
In quegli anni era riuscita a ritrovare un po' di normalità quotidiana?"Non è stato facile. Per sfuggire all'assedio della stampa ho dovuto cambiare casa e mettere le bambine in una nuova scuola. Eravamo una famiglia di sole donne, noi tre più mia madre e una gatta, che cercavano di far barriera contro le ostilità esterne".
Che cosa l'aveva più colpita?
"C'era stato il tentativo di infangarmi per rendermi meno credibile. Il giudice Caizzi, invece di cercare la verità mi aveva chiesto se avevo degli amanti. Mia suocera poi era stata fermata per strada da uno sconosciuto che le aveva detto: 'Lo sa che sua nuora quella sera era con un altro uomo?'".
Ma aveva anche molte persone che la sostenevano. Pinelli era diventato un simbolo.
"Sì, mi stavano vicino i vecchi amici e poi erano arrivate persone nuove, di un ambiente diverso, come gli avvocati, come Camilla Cederna. Dopo la sua morte è stata volutamente dimenticata, non le hanno perdonato di aver scritto con tanta maestria di Pinelli e di piazza Fontana".
Dario Fo ha raccontato la storia di suo marito in un testo grottesco, 'Morte accidentale di un anarchico', che ha contribuito a fargli assegnare il Nobel e che è ancor oggi uno dei lavori più rappresentati al mondo. Si è mai chiesta perché?
"Perché non è una vicenda solo italiana. L'ingiustizia e gli abusi del potere ci sono dappertutto".
Nel libro Sofri ricostruisce i tre giorni di suo marito in questura. Lei che cosa ricorda?
"Fino alle ultime ore non ero molto preoccupata. Pino aveva telefonato più volte per rassicurarmi, aveva una voce calma. Erano anche venuti i poliziotti a frugare in casa e si erano accaniti su una delle tesi di laurea che battevo a macchina per gli studenti della Cattolica. Credo parlasse di una rivolta contro lo Stato Pontificio nelle Marche, ma loro l'avevano presa per un documento sovversivo".
Da chi aveva saputo del volo dalla finestra?
"Da due giornalisti, arrivati all'una di notte. Mi ero precipitata a chiamare in Questura, chiedendo di Calabresi. Me l'avevano passato subito. Chiesi cos'era successo e perché non mi avevano avvertito. 'Sa signora, abbiamo molto da fare', era stata la risposta. La verità è che intanto il questore Guida stava preparando la famosa conferenza stampa dove disse che Pinelli si era ucciso perché schiacciato dalle prove. Il 28 dicembre l'avevo querelato per diffamazione. Ma anche se intanto avevano dovuto ammettere che Pinelli non era colpevole, Guida era stato assolto".
'Le ultime parole' è il titolo di uno dei capitoli del libro di Sofri. Pensa che suo marito abbia cercato di dire qualcosa prima di morire?
"Non ne ho nessuna prova. Quel che so è che non hanno lasciato entrare nella stanza mia suocera, che era corsa in ospedale mentre io portavo le bambine a casa di amici. Finché Pino non è morto, vicino al suo letto ci sono stati i poliziotti. Solo quando tutto è finito hanno aperto la porta".
Sofri conclude il suo lavoro rispondendo con tre semplici parole, "non lo so", alla domanda su come è morto Pinelli. E lei cosa risponde?
"L'ho detto anche ai giudici che me l'hanno chiesto, ne sono così convinta che è come se l'avessi visto con i miei occhi. L'hanno colpito, l'hanno creduto morto e l'hanno fatto volare dalla finestra. Solo qualcuno che era in quella stanza può raccontare la verità, non ho mai smesso di sperarlo".
1 2 3
Pagina 3 di 3
(15 Gennaio 2009)
12 dicembre 2005
Strage fascista senza un volto
di Corso Bovio e Caterina Malavenda
Dopo 36 anni chiusa definitivamente dalla Cassazione una delle pagine più nere della storia italiana. Con una decisione prevedibile. Parlano gli avvocati di parte civile
È finita com'era prevedibile, soprattutto dopo le accorate, ma ferme parole del Procuratore Generale: tutti assolti. La cosa più difficile è ora spiegare ai familiari delle vittime ed in particolare alle nostre assistite che ci hanno creduto, ad una intera città, che in prima linea ha voluto esserci, con il Comune di Milano, insieme ad altri Enti pubblici costituitosi in giudizio, che la strage che ha segnato un'epoca, dopo 36 anni, non ha un colpevole. Tutti coloro che quel 12 dicembre del 1969 si trovavano in prossimità di Piazza Fontana ricordano il tremendo boato, ma nessuno di loro saprà mai chi e perché mise la bomba.
Gli sforzi congiunti di giudici e forze dell'ordine, passati attraverso anni di serrate indagini, hanno avuto un solo esito: Carlo Digilio, l'uomo che per primo aprì uno squarcio nell'ambiente in cui quella strage era maturata, che ha ammesso le proprie responsabilità, che ha fornito preziosi elementi, è processualmente il solo che i giudici non hanno ritenuto innocente, dichiarando prescritto il reato contestatogli. Rimangono sullo sfondo, richiamati nel capo di imputazione, Franco Freda e Giovanni Ventura, definitivamente assolti e dunque innocenti. Nella querelle di questi giorni fra Gerardo D'Ambrosio e Giulio Andreotti sono rispuntati persino Pietro Valpreda ed il suo cappotto.
Nel silenzio che ha seguito la lettura del dispositivo, ciò che, assurdamente, ha attirato l'attenzione di tutti i commentatori a caldo, è la sola sulla quale i giudici non avevano alcuna scelta: la condanna delle parti civili private al pagamento delle spese processuali.
Quando un ricorso per Cassazione viene respinto, la condanna per chi lo ha promosso al pagamento delle spese di cui lo Stato ha dovuto farsi carico per dare corso all'impugnazione, è automatica. La Suprema Corte anzi, là dove ha potuto, ha limitato le conseguenze per chi ha perso un familiare senza un perché e senza un responsabile.
Non ha, infatti, condannato le parti civili al pagamento alla Cassa delle ammende di una ulteriore somma, che può essere posta a carico di chi ha proposto un ricorso infondato: una "punizione" per avere messo in moto inutilmente l'apparato giudiziario. L'iter processuale è stato, fin dall'inizio, piuttosto tormentato, nello sforzo di individuare eventuali connessioni fra i possibili autori della strage ed i servizi segreti. Lo sforzo profuso in tale direzione non ha, però, convinto i giudici di merito. Assai più "resistente" era parsa, invece, la trama offerta dalle ricostruzioni di Carlo Digilio e di Martino Siciliano, che hanno scelto di collaborare con la giustizia, ciascuno dei due osservatore, da un punto di vista privilegiato, dell'area nella quale, questo è almeno stato accertato, la strage è maturata.
Quanto costoro hanno dichiarato - Martino Siciliano in particolare è stato ritenuto un teste estremamente attendibile - aveva convinto i giudici di primo grado a condannare gli imputati, con una motivazione organica e complessa. Così non è accaduto con i giudici di appello, i quali hanno preferito ripercorrere i fatti con metodo analitico, valutando ciascuno di essi, nella prospettiva offerta dall'accusa e la trama non ha retto alla verifica. Se uno storico può accontentarsi di una ricostruzione fondata su elementi verosimili e su una visione d'insieme, i giudici no. Posti di fronte all'alternativa se assolvere o condannare all'ergastolo persone ormai lontane, per età e fatti della vita, dai giorni in cui la società ribolliva di opposte contraddizioni, hanno dovuto scavare a fondo e cercare prove certe ed inoppugnabili. In assenza di queste, coscienza e diritto hanno imposto loro di assolvere, sia pure per "insufficienza di prove", coloro che sono stati indicati, dopo tanti anni ed in modo a volte contraddittorio, come i responsabili della prima, efferata strage che la nostra Repubblica ricordi. Uno Stato di diritto non può cedere all'emozione e tuttavia lo stesso Stato deve comprendere lo sconforto e l'amarezza che ha colto, questa volta senza ulteriori speranze, coloro che da 36 anni piangono i loro morti e farsi carico - da più parti lo si è auspicato - eccezionalmente almeno delle spese processuali. *Avvocati di parte civile.
1 2
Pagina 2 di 2
(12 Dicembre 2005)
22 settembre 2005/Gli intrighi
Delfo Zorzi connection
di Alessandro Gilioli
L'ex terrorista nero latitante in Giappone fa affari in Italia. Grazie a una rete di società e di negozi tra Milano, Roma e il Veneto. Con molte ombre e giri di denaro sospetti
Il negozio di griffe modaiole si chiama Oxus ed è in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, accanto al Biffi. Pochi scaffali eleganti coperti di borsette costose, un paio di commesse carine. Nessuno, passando di lì, immagina che dietro quella vetrina si possa stagliare l'ombra di uno dei latitanti più famosi d'Italia: Delfo Zorzi, già esponente di Ordine Nuovo, condannato per diversi attentati neofascisti in Veneto, imputato per la strage di piazza della Loggia a Brescia (1974, otto morti e quasi cento feriti), assolto - con sentenza definitiva, ma tra mille dubbi e dopo una condanna in primo grado all'ergastolo - per l'eccidio di piazza Fontana a Milano (12 dicembre 1969, 17 morti e 84 feriti).
Da anni Zorzi vive in Giappone con il nuovo nome di Hagen Roi. Su di lui pende una richiesta di arresto confermata di recente dalla Cassazione, ma non può essere estradato in Italia perché ormai ha il passaporto giapponese, acquisito tramite matrimonio. Di lui si sapeva che, dai suoi uffici di Tokyo, controlla una serie di società legate all'import-export, ai duty free e alla moda. Si sapeva anche che è miliardario e vive nel lussuoso quartiere di Ayoama, protetto dal governo giapponese. Ma ora "L'espresso" ha scoperto che gli affari di Zorzi riguardano molto da vicino anche il suo paese d'origine, l'Italia, dove l'ex militante nero continua a svolgere le sue attività, con legami poco chiari che portano al mondo dell'importazione parallela illegale e, secondo alcuni, anche ad ambienti del riciclaggio. Il segreto dei contatti tra Zorzi e l'Italia è custodito tra i dipendenti e nei corridoi della Gru.p. Italia, un'azienda di pelletteria con uffici a Milano e a Roma, formalmente controllata da società anonime con sedi in Svizzera, in Lussemburgo, a Madeira, nell'isola di Mann e nelle Vergini britanniche.
Gru.p. Italia produce principalmente borse, sia con un marchio proprio (Oxus, appunto) sia come licenziataria di griffe più famose, tra le quali Laura Biagiotti, Luciano Soprani, Gianmarco Venturi e in passato anche Valentino e Antonio Marras. Oltre al negozio di Milano, Oxus ha boutique anche a Roma (vicino a piazza Fiume) e in Veneto, nelle zone da cui proviene Zorzi: uno a Conegliano e uno a Pordenone.
A Mestre c'è invece la Legrenzi boutique, di cui fino a poco tempo fa si occupava il nipote di Delfo, Erik. Anche il deposito dei prodotti è da quelle parti: a Salzano, a poche centinaia di metri dall'ultimo indirizzo italiano di Zorzi e dal magazzino del fratello Rudi, pure lui nel business dei pellami. Curioso che l'unico negozio fuori dall'Italia del gruppo si trovi in Colombia, a Bogotà, capitale non particolarmente nota per il mercato di marchi di moda. In Colombia si era nascosto Martino Siciliano, il pentito che prima aveva accusato Zorzi delle stragi e poi aveva ritrattato dietro compenso. A Gru.p.
Italia fanno capo anche un paio di fabbriche all'estero: una a Seia, in Portogallo, dove vengono prodotte le prime linee, e una a Uzgorod, in Ucraina, dove una quarantina di ragazze locali tagliano e cuciono borsette di cuoio in un ex mobilificio . Fino a due anni fa gli affari della ditta nell'ex repubblica sovietica erano curati da Alberto Caner, amico di lunga data di Zorzi, poi un litigio per una questione di capi mancanti (forse rivenduti sui mercati minori) ha messo fine al rapporto tra i due. Gli uffici amministrativi e il laboratorio di conceria in cui si creano i prototipi sono invece a Milano, in via Riva di Trento 13, dietro corso Lodi. È in questa anonima palazzina marrone su due piani, controllata da una videocamera, che opera Daniela Parmigiani, che ha 58 anni come Zorzi, di cui in gioventù sarebbe stata fidanzata.
Nata a Mantova, abita a Milano, non lontano dall'azienda, ma possiede una villa a Mendrisio, in Svizzera, e risulta residente a Lugano. Oggi è una signora dal look eccentrico e in evidente sovrappeso, con i capelli tinti e alcuni chili di gioielli addosso. Al polso, un cellulare a conchiglia incastonato in una fascia di pelle rossa: è a quel telefonino che, raccontano alcuni degli impiegati del gruppo, ogni sera Zorzi la chiama dal Giappone per avere il rendiconto della giornata, il venduto, i nuovi contatti. È lei l'amministratrice unica di quasi tutte le società italiane della galassia, battezzate con nomi della mitologia pagana tanto cara all'ex estremista nero: Oxus, appunto, come il fiume-dio nato, secondo una leggenda, dalla bocca di un cavallo di lapislazzuli; o Ygg drasil, albero sacro della tradizione vichinga. In stretti rapporti con Gru.p. Italia è anche la Hobbit, che ha sede a Marsiglia: un omaggio allo scrittore di fantasy John Tolkien, amato dai ragazzi di estrema destra negli anni '70. Zorzi non ha mai fatto mistero della sua passione per la cultura indoariana, anche nelle sue declinazioni germaniche: il nome che ha scelto per sé, Hagen, è quello dell'eroe che nei Canti dei Nibelunghi si fa uccidere piuttosto che rivelare i suoi segreti; la figlia di Zorzi si chiama Sigfrida; il maschio Eginardo.
E sono proprio i due ragazzi, insieme alla madre, a rappresentare uno dei tramiti del latitante con l'Italia: le loro visite in azienda a quanto pare non sono rare, dato che studiano in Inghilterra e non hanno problemi con la giustizia. In Gru.p. Italia, raccontano alcuni degli impiegati, si è vista spesso anche la moglie del super latitante, Shimoji Yoko, originaria di Okinawa, una donna minuta dai capelli neri, che veste all'occidentale e parla un discreto italiano.
Lo stesso Zorzi non avrebbe resistito alla tentazione di venire più volte in Italia nonostante il rischio di essere arrestato: in azienda si dice che un fattorino del gruppo lo vada a prendere un paio di volte l'anno a Mendrisio e gli faccia attraversare il confine nel modo più sicuro possibile. Altre volte Zorzi e Parmigiani si darebbero appuntamento a Hong Kong, uno degli epicentri delle attività dell'ex ordinovista, o direttamente in Giappone, dove Zorzi è sospettato di essere uno dei maggiori burattinai del mercato delle griffe falsificate: un giro che in Estremo Oriente fattura ogni anno parecchi miliardi di euro e per il quale l'ex estremista italiano è stato denunciato più volte.
Insieme a Daniela Parmigiani, Zorzi è stato denunciato anche in Italia, nel '95, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e usura, per un finanziamento offerto a Maurizio Gucci (l'imprenditore poi assassinato dall'ex moglie) in cambio dello sfruttamento della sua griffe sui mercati asiatici. Sulle attività locali di Gru.p. Italia e delle sue consociate la nebbia è piuttosto fitta. Il bilancio parla di un fatturato di una decina di milioni di euro e di un leggero attivo, ma è il modo in cui il denaro entra ed esce dalle casse aziendali a destare qualche perplessità. Come licenziataria di grossi marchi, Gru.p. Italia si impegna a vendere nei suoi negozi o a terzi un minimo garantito di capi che non viene mai raggiunto. Per pagare fornitori e debiti l'azienda farebbe allora ricorso a una serie di prestiti assai ingenti - dai cinque ai dieci milioni di euro a botta - che vengono erogati dalla Vega, una società giapponese (il cui nome rimanda a un battaglione della X Mas repubblichina) che a Tokyo è nota per far capo allo stesso Zorzi. A questo punto, per far quadrare i bilanci, Gru.p. Italia cederebbe a questa generosa società nipponica le borse invendute come saldo del prestito precedentemente ottenuto. Si tratta di collezioni vecchie e fuori mercato, almeno in Europa.
In questo modo Gru.p. Italia raggiunge il minimo garantito con i grandi marchi e può continuare ad esserne licenziataria, ma soprattutto fa girare una tale quantità di denaro tra Milano, Tokyo e la Svizzera da rendere plausibile l'ipotesi che l'azienda serva anche a qualcosa d'altro rispetto alla semplice produzione e vendita di pellami. Del resto sono alcuni degli stessi impiegati del gruppo a raccontare come Daniela Parmigiani abbia chiesto loro di effettuare frequenti consegne a mano di buste piene di contanti, a Roma o in Canton Ticino, a intermediari e faccendieri che danno appuntamenti agli angoli delle strade e mai in una sede. Unico recapito accertato di questi passaggi, gli uffici di Lugano della Vega, dove opera tale Milena, contabile in Svizzera della società giapponese. Il clima nell'azienda a Milano, a quanto pare, non consente di ribellarsi a questo tipo di impegni e chi non dimostra di accettare la situazione viene presto allontanato.
In compenso, la numero uno Parmigiani non si sforza più di tanto di far mistero sui suoi stretti contatti con Zorzi, tanto che alla notizia della sua assoluzione in appello per la strage di piazza Fontana, raccontano, è uscita entusiasta dal suo ufficio per annunciare la buona nuova a tutti e ha festeggiato con i dipendenti offrendo caraffe di Negroni al bar accanto all'azienda. Unico accorgimento: nessuno deve mai nominare mai l'ex esponente di Ordine Nuovo né con il suo nome italiano né con quello giapponese. Sicché per tutti, in via Riva di Trento, lui è soltanto "il Gm": acronimo di una carica (quella di General manager) che naturalmente Zorzi non ricopre ufficialmente.
È per il "Gm", ad esempio, il primo pensiero mattutino delle segretarie, che - si racconta - appena arrivate in ufficio hanno il compito di infilare in una busta gialla di tipo "airball" una copia fresca del "Corriere della Sera", che viene immediatamente spedita in Giappone. Accanto alla Parmigiani, in Gru.p. Italia opera un dirigente di rilievo, Giuseppe Olivero, uomo di fiducia per creare e liquidare società e partecipazioni. Un altro manager, Davide Del Grano, già direttore amministrativo, fino a qualche anno fa si occupava della parte contabile ed è oggi un consulente. A Zorzi non mancano, nonostante il trentennio di latitanza, anche amici in altre aziende del settore: come Paolo Giachini, un marchigiano oggi cinquantacinquenne, vicino a Zorzi tanto nella militanza di estrema destra quanto nel lavoro (anche lui commerciava in pellami). Giachini è uno dei pochi che, parlando con "L'espresso", ammette di aver fatto affari "con aziende di Zorzi tra cui Gru.p. Italia", e quindi rivela che - almeno nel suo ambiente - i reali rapporti tra l'azienda di Milano e l'ex ordinovista non erano un mistero. Tra l'altro Giachini è noto per essere l'uomo che nella sua casa di Roma ospita agli arresti domiciliari Erich Priebke, l'ex ufficiale tedesco corresponsabile della strage delle Fosse Ardeatine (335 civili uccisi, nel 1944). Strani intrecci davvero, quelli tra il commercio della pelletteria e il vecchio giro fascista. Legami che hanno del resto origini assai lontane. Anche Massimiliano Fachini, il neonazista veneto esperto di esplosivi condannato per associazione sovversiva e banda armata, faceva affari internazionali con capi di cuoio e borse.
E nell'ambito delle indagini sulla strage di piazza Fontana è emerso che Delfo Zorzi nascondeva un esplosivo, la gelignite, proprio in un laboratorio di pelletteria di famiglia, sulla strada tra Spinea e Mirano, sempre nel mestrino. Tutti particolari che all'epoca delle inchieste sulle stragi erano sembrati di relativa importanza, ma che oggi possono gettare una luce diversa sulla storia e sugli affari di un ex terrorista che custodisce tanti segreti. E che come il suo eroe nibelungico, il mitico Hagen, non ne rivelerà mai neanche uno..
1 2 3 4
Pagina 4 di 4
(22 Settembre 2005)
19 maggio 2005
Un’Italia torbida
di Enzo Biagi
Anche la bomba di piazza Fontana a Milano è rimasta ufficialmente senza colpevoli
Approfondimenti
LEGGI Il mondo non ha più isole felici (25 marzo 2004)
Trentasei anni, 11 processi e alla fine tutti assolti per la strage di piazza Fontana.
Ha detto l'avvocato Franco Coppi, difensore di alcuni familiari delle vittime: "Non c'è più niente da fare, è un discorso definitivamente chiuso. Una strage ufficialmente senza colpevoli". Non racconto il fatto: lo sanno tutti.
12 dicembre 1969: piazza Fontana. Milano era in festa, panettoni e dolci di Natale. Scoppiò una bomba nel salone degli sportelli, alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Sedici rimasero per terra. C'erano le file: piccola gente, la cambiale, il libretto di risparmio, la pensione. Migliaia di persone ai funerali. Guardavo la folla riunita sulla piazza del Duomo di Milano, mentre sfilavano le bare, i poveri morti dell'attentato: quei volti, quel silenzio, quella compostezza, facevano capire che la pena era di tutti: "Sono italiani", disse un uomo, e io capii che voleva dire: "È un lutto nostro"; e la bandiera era come la targa sulla porta di casa, parlava di una famiglia. Il bilancio tragico, finale: 17 morti e 84 feriti, le piste: anarchici e neofascisti.
Le indagini coinvolsero all'inizio il ferroviere Giuseppe Pinelli che morì in circostanze poco chiare (così si diceva) tre giorni dopo la strage, precipitando da una finestra della Questura. Chiesi alla vedova, la signora Licia: "Come ha raccontato alle sue figlie i fatti, la storia di quella notte?". "Così, semplicemente, senz'odio, senza scene. È caduto, è difficile che si salvi. La nonna le voleva consolare, ma Silvia, la più grande, era disperata: "Se non guarisce, non lo vedrò più". No, poi non dissi: "Si è ucciso", ma è morto". Che cosa hanno scritto sul certificato, sui documenti per spiegare? "Deceduto". Incontrai anche il ballerino Pietro Valpreda, il maggiore indiziato, che fu arrestato per primo. Per mandarlo fuori dovettero addirittura inventare una legge. Abitava in una vecchia casa di corso Garibaldi, coi cortili dove passeggiano i gatti e le balconate milanesi che fanno venire in mente i poveri delle commedie di Bertolazzi, o gli sconfitti di De Marchi. Due camere, che aveva imbiancate, ripulite, coi pavimenti di cotto rosso, nella culla c'era il bambino che dormiva, Tupac Emiliano Valpreda. Al centro del tavolo la fruttiera con le mele e le arance, su una parete il ritratto di Errico Malatesta. Una conversazione facile: passò subito al tu, mi chiese se avevo preso il caffè, insistette per il whisky "perché", diceva, "non voglio che poi racconti che non ti ho nemmeno offerto da bere". C'era nella stanza una donna anziana che si presentò: "Sono socialista, lo conosco da quando era piccolo, conoscevo anche suo nonno, questo non ammazza neppure una mosca. Che coglionata". Gli chiesi: "Che cosa ti porti dietro del carcere?". "I 45 giorni di isolamento, e poi i primi mesi del '72. Mentre ero là ho ricevuto centinaia di lettere, di ogni genere: "Dovresti avere l'ergastolo", uno mi augurava la morte.
E tutto era cominciato quella volta che mio zio mi aveva portato un giornale con un grande titolo, tanti morti a piazza Fontana, e io mi indignai e dissi: adesso danno la colpa a noi anarchici".
Cercai di parlare anche con Giancarlo Stiz, l'istruttore che aveva capovolto l'andamento delle indagini, dando ascolto alle relazioni di un sostituto ai primi passi, Guido Calogero, che aveva cominciato a scoprire l'itinerario delle "piste nere", ma non voleva saperne di giornalisti. Aveva i suoi buoni motivi. La campagna di stampa che gli avevano scatenata contro aveva colpito particolarmente la moglie che era molto malata. Intanto Franco Freda e Giovanni Ventura, i due protagonisti, erano in cella a San Vittore. Leggevano, studiavano. Ventura aveva avuto modo anche di sposarsi, di seguire corsi di filosofia, e Freda, sempre gelido, controllato, faceva dell'ironia: "Matrimonio non valido perché non consumato". Durante l'ora d'aria, Freda si intratteneva con quel Bertoli che aveva lanciato la granata davanti alla Questura di Milano. A Bologna andai a trovare l'avvocato Giancarlo Ghidoni, che aveva accettato di difendere Ventura. Ghidoni non voleva che gli attribuissero affinità di idee con lo scomodo cliente di cui apprezzava però certe qualità umane: diceva che era gentile, sensibile, un intellettuale, forse debole.
Nell'inchiesta, si sono trovati di fronte, alla ricerca della verità, o di una quasi impossibile difesa, giovanotti che avevano frequentato le università nelle stesse stagioni, che avevano fatto, credo, identiche letture, uguali incontri culturali, perché appartenevano a un'unica generazione: i sostituti procuratori Calogero, D'Ambrosio, Alessandrini e Fiasconaro, da una parte, e dall'altra gli imputati Freda e Ventura. I discorsi erano, si può dire? quasi sportivi: rispettosi. "Bravi", diceva Freda davanti a sottili contestazioni, o a sorprendenti rilievi. "Complimenti, però io non ammetto nulla". Quando depositarono la requisitoria che rinviava a giudizio il procuratore legale Freda, di Padova, e l'editore Ventura di Treviso, furono contati 400 fogli battuti a macchina. Ma gli avvocati ne hanno studiati migliaia. Questi fascicoli narrano una intricata vicenda e descrivono una Italia torbida: agenti stranieri ed esaltati giovanotti di provincia; ideologi che rimescolano Nietzsche, Evola e le "soluzioni finali" di Himmler; ragazzi della borghesia veneta, frustrati da un'ottusa educazione familiare e spregiudicata, personaggi pronti a sfruttare le situazioni. Storie passate, difficili da dimenticare..
1 2
Pagina 2 di 2
(19 Maggio 2005)
25 marzo 2004
Il mondo non ha più isole felici
di Enzo Biagi
Dopo più di trent'anni stiamo ancora discutendo della strage di piazza Fontana a Milano
Tanto gentile e tanto onesta
8 marzo, s. Giovanni di Dio
8 marzo: festa della donna. Il presidente Ciampi esorta gli uomini: "Si impegnino nella cura delle case". Ha dei predecessori; già Mussolini diceva: "Se le culle sono vuote la nazione decade". E c'era un distintivo anche per i padri di famiglia numerosa, che qualcuno attribuiva all'organo della riproduzione maschile. Si comincia a trattare l'argomento sui banchi di scuola: "Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori/ le cortesie, le audaci imprese io canto"; "Tanto gentile e tanto onesta pare/ la donna mia"; "Meglio era/ sposar te, bionda Maria...", e poi si continua. Sarà il tema di tutta la vita. "L'italiano di una donna non può proprio fare a meno: prima la mamma, poi la moglie, l'amica, fino all'ultimo quando la buona suorina gli chiude gli occhi", dice Lina Wertmüller. In Italia il 90 per cento delle coppie resiste fino alla morte: il doppio di quanto si verifica in Germania o in Inghilterra. La donna meridionale si sente più realizzata, quella del Nord, secondo i sondaggi, ha due anime: forte e volitiva, tesa a conquiste concrete e critica nei confronti delle regole attuali. Come vuole il compagno ideale? Deve essere "stimolante". Schema della sua giornata: 7 ore e 44 minuti di sonno, 5 ore per marito e figli, 2 ore per mangiare e per se stessa, un'ora e 47 minuti per leggere, guardare la tv, fare sport, 96 minuti per cercare un parcheggio o aspettare un tram; il resto è lavoro. Ci sono più donne nel nostro Parlamento che in quelli in Usa, Francia, Germania e Giappone. Ecco una visione di Fellini: "La donna è anche uno specchio, perché rappresenta la parte più oscura di te, perché è anche quello che abbiamo fatto di lei. Ne ho rispetto profondo, la considero migliore, più innocente, più naturale, più vera: più vicina anche al senso religioso della vita, e credo non abbia mai colpa".
Debiti per vivere
9 marzo, santa Francesca Romana
Una famiglia su cinque fa debiti per vivere. Negli ultimi due anni le richieste di prestiti, scrive "Il Messaggero", sono salite del 20 per cento per arrivare alla fine del mese, non per svaghi o delizie. Da fonti ufficiali risulterebbe invece che siamo più ricchi. Ma sono, secondo me, dichiarazioni autobiografiche. Sono nato e cresciuto in una famiglia operaia e so che cosa sono i "sacrifici". Uno era tipico e ritornava ogni tanto: risparmiare sul quotidiano, niente giornale, e ci fu un tempo in cui costava anche quattro soldi. In casa Biagi era un tentativo che si ripeteva nei giorni di magra, quando aspettavamo la paga del babbo. Ma dopo un po' mia madre lo ricomperava perché alla mancanza del giornale non sapeva resistere. Forse è anche da questa sua ostinazione è nata la mia passione per il mestiere che ha segnato la mia vita.
Padri in caduta libera
10 marzo, san Simplicio
Nel 1968, Daniel Cohn-Bendit, anarchico e teorico della contestazione studentesca, proclamò: "Genitori buoni da mettere in soffitta, non crediate che le vostre aspirazioni autoritarie e repressive legittimate dalla passività, possano frenare le forze scatenate dei vostri figli. La libertà che non avete saputo concedere loro se la sono presa e se la tengono". La figura che ha più subito questa caduta di autorità è quella del padre: non sta più al vertice. Finché vivevo con lui, faceva continuamente ricorso al ricatto economico: "Io ti do da mangiare, da vestirti, da divertirti, e tu devi fare quello che voglio io", ha detto un ventenne al primo impiego. E una studentessa: "Mio madre detiene saldamente la chiave di una cintura di castità per delega di un uomo ancora sconosciuto, il mio futuro marito". I sentimenti dominanti erano l'obbedienza e il rispetto; più degli affetti e della stima. Il padre rappresentava l'immagine della forza, della giustizia, della bontà, puniva e premiava, entrava in ogni scelta, della professione o del compagno dell'esistenza, insegnava alla femmina che il matrimonio doveva rappresentare un punto d'arrivo e che era, per tutti e due, uno scambio di servizi. Anche il mondo fisico nel quale la famiglia si muoveva è mutato; la cucina è sempre più piccola, si consumano meno pasti insieme, sono scomparsi i salotti "buoni", con i loro convegni, e la camera da letto è sempre più un luogo di passaggio, nel quale ha fatto irruzione il "sommier". In molte ore la casa è certamente deserta: chi è all'asilo, o a scuola, o al lavoro, o all'ospizio dei vecchi.
La morale delle patate fritte
11 marzo, san Costantino re
I due scandali del momento, Parmalat e Cirio, mi fanno venire in mente anche un detto popolare: "Viva la Franza, viva la Spagna, pur che se magna". Questo è un paese che ha conosciuto la guerra e la fame. Quando morì mio padre io dovevo pensare alla mamma e a un fratello più piccolo: avevo ventun anni. Ricordo che il mio padrino della cresima mi regalò una bottiglia d'olio: un dono prezioso. Ero un giovane redattore del "Resto del Carlino" e una notte, chiacchierando con Giannino Zanelli, il mio redattore capo, dissi: "Cosa pagherei per un piatto di patate fritte". Mi rinfrancò subito: "Quando abbiamo "chiuso" il giornale andiamo a casa mia. Ti caverò la voglia". Credo di averne sbucciate un secchio, e ne mangiai a sazietà: poi la notte, credevo di morire. Non ero più abituato a un pasto abbondante.
Se uno mi chiedesse un esempio di indifferenza racconterei quando con un compagno partigiano di "Giustizia e Libertà" finimmo un mezzogiorno a casa di un contadino. Portarono in tavola polenta e salsiccia: non ci chiesero se ne volevamo. Loro mangiavano e noi sudavamo freddo. Forse è anche per certi, in fondo, trascurabili episodi che detesto le formule "storiche". Ad esempio: "Guerra di popolo". Dipende.
Paradossi storici
12 marzo, san Massimiliano
Questa, forse, non la sapevate. È aumentato il prezzo della benzina e paghiamo ancora la tassa per la guerra in Abissinia. "O bella venditrice di banane, mogadisciane", cantavano quando l'impero tornava a splendere glorioso "sui colli fatali di Roma".
Ricordo il tripudio quando sbarcarono alcuni sacchi di caffè di Harar, e mio padre andò a Roma con gli ex combattenti della guerra 1915-18, e tornò felice ed esaltato perché aveva visto sfilare le truppe coloniali, i dubat. Avevano, mi pare, anche i cammelli. Di quei tempi eroici ci sono rimaste ancora la tassa, con un supplemento, per la crisi di Suez (1956). Chi sa che non dobbiamo fare qualcosa anche per i compianti antenati celti, e un risarcimento postumo ai sabini ai quali i legionari romani rapirono le mogli. Conquistatori, ma con le donne sfortunati. Del resto, la storia è piena di paradossi: chi sa il nervosismo di Garibaldi per arrivare ai mille, chi sa le sghignazzate delle amiche quando Cornelia, madre dei Gracchi, mostrava i ragazzi e diceva: "Questi sono i miei gioielli" e quelle pensavano: "Attaccateli al collo", e se Enrico Toti, che il buon senso avrebbe voluto nei servizi sedentari, dato che gli mancava una gamba, invece di lanciare una stampella al nemico gli tirava una banana, addio ai testi scolastici.
E lasciamo perdere Muzio Scevola che per punirsi, dopo aver sbagliato la mira, poggia la mano nel caldano. Non gli era passato per la mente che è la testa che prende la mira?
El Pozo, S. Eugenia, Atocha la via crucis spagnola
13 marzo, santa Claudia martire
Lo chiamano "fattore T." sta per terrorismo. Non risparmia nessuno. Ultimo paese vittima è stata la Spagna. Come ogni storia ha una protagonista, che diventa un simbolo. È Patricia, una piccola di sette mesi, che una poliziotta di Madrid ha raccolto su un marciapiede della stazione di El Pozo. Chi sono i responsabili? L'Eta o Al Qaeda? E poi, dove si nasconderà il pericolo, l'insidia? Dopo l'attentato alle Torri gemelle pareva che solo l'America dovesse affrontare il pericolo. Adesso gli attacchi terroristici e le carneficine ad El Pozo, Santa Eugenia e Atocha (dieci esplosioni su tre convogli di pendolari: quasi 200 morti. E 1.100 feriti) ci fanno capire che nel mondo non esistono luoghi sicuri e isole felici. Dopo più di trent'anni stiamo ancora discutendo della milanese strage della Banca nazionale del lavoro.
I fatti dopo tante promesse
14 marzo, Terza di Quaresima
Forse è vero: mancano i capi, le figure rappresentative. Credo sia difficile fare il leader e anche diventarlo. Dietro ai Togliatti, ai Nenni o ai De Gasperi c'erano l'esilio e le galere e poi la guerra di Spagna e la Resistenza e poi, per fare il caso di Berlinguer, un'educazione morale ricevuta dalla famiglia che faceva scegliere, fin dall'adolescenza , una certa parte. È finita l'epoca del comizio, dei venditori dell'"Unità" della domenica, dei volontari dei festival e delle piadine: stiamo vivendo la stagione della tv e del "Grande Fratello". Ma c'è sempre chi aspetta il messaggio della speranza, e c'è un forte bisogno di giustizia. Non è necessario, per saperlo, ricorrere ai sondaggi: può bastare anche un vecchio cronista. Dopo tante promesse, qualche fatto..
1 2 3
Pagina 3 di 3
(25 Marzo 2004)
16 dicembre 1999 - IL DOSSIER
Le bombe senza verità
di Giampaolo Pansa
Sedici morti e 84 feriti. La pista anarchica. Il vomito di Valpreda. La morte di Pinelli. Il tassista terrorizzato. I processi inutili. E le radici di tanti misteri italiani
Mandorle amare. Proprio cosÌ: un odore pungente di mandorle amare. Questo sentivo mentre camminavo a passi di formica dentro un inferno che non avevo mai immaginato. E seguitavo a domandarmi, scioccamente: dove saranno nascoste, le mandorle? Solo anni dopo avrei scoperto cheper fare la strage di piazza Fontana era stata usata la gelignite, e che quell'esplosivo contiene il binitrotoluolo che ha, per l'appunto, questo odore. Ma nel pomeriggio del 12 dicembre 1969, giusto trent'anni fa, era la ricerca delle maledette mandorle a guidarmi nel mio vagare alla cieca dentro il carnaio della Banca nazionale dell'Agricoltura. Fra corpi mutilati, sventrati, ustionati o che bruciavano ancora. Sedici morti e ottantaquattro feriti: sarà questo il conto finale. Alle cinque del pomeriggio erano lì, sotto i nostri occhi increduli di giovani cronisti. Che si domandavano: perché siamo qui, a rovistare nel sangue?, chi può aver voluto questo sterminio?
Poi il mestiere ebbe il sopravvento. Dovevamo raccogliere le notizie, scrivere, spedire gli articoli, e anche l'orologio era nostro nemico. Avevamo poco tempo, il buio calava su Milano, i capi dei giornali tempestavano: fate presto, presto, presto! Del mio lavoro di quella sera non ricordo quasi nulla. Ero in trance, come ubriaco, quasi drogato. Non mi era accaduto così nemmeno al Vajont, sei anni prima, eppure lì avevamo sott'occhio un intero paese scomparso, una valle coperta di fango e duemila cadaveri. Sono andato a rileggermi il mio primo articolo su piazza Fontana: ero stato l'unico della "Stampa" ad arrivare subito sul posto e, dunque, mi era toccato il cronacone della strage. Ma nel rivedere quelle righe, mi sono chiesto se le avessi davvero scritte io o un altro me stesso, scomparso anche lui dopo la bomba. E così mi resterà nella mente soltanto l'incitamento di Alberto Ronchey, che dirigeva "La Stampa" da un anno. Scoprii che galantuomo fosse quando, a giornata finita, ci disse: "La nostra linea dev'essere quella del dubbio. Non dobbiamo accettare nulla a occhi chiusi. Tantomeno ciò che sentiremo dalla polizia".
Ma si capì subito che tanta gente di dubbi non ne aveva. Questo lo ricordo bene. La notte su Milano. Un cielo gonfio di nuvole nere. La cappa di smog. I lampioni dalla fioca luce gialla. I deboli fari dei tram. Piazza Fontana zeppa di fascisti che davano la colpa ai rossi. Urla. Assalti. Pestaggi. Rammento un senatore del Pci, Gianfranco Maris, oggi difensore di Leonardo Marino. I neri tentarono di fracassargli la faccia, lui si difese, poi fu costretto a salvarsi pure dai poliziotti decisi ad ammanettarlo. Risultò chiaro che stare a sinistra era indiziante. "Indaghiamo in tutte le direzioni!" strillavano i capi della questura di via Fatebenefratelli. Ma la direzione di marcia era una sola: le "frange anarcoidi". Secondo uno schema che più lineare non si poteva: dalle bombe del 25 aprile alla Fiera di Milano, a quelle di agosto sui treni, fino alla strage di piazza Fontana.
Tra gli anarchici condotti in questura la sera del 12 dicembre c'era anche un tale Giuseppe Pinelli. Per tre giorni rimase uno dei tanti, dato che nessuno dei giornali lo conosceva.
Solo dopo imparammo qualcosa di lui: 41 anni, capofrenatore alla stazione di Porta Garibaldi, una moglie, due figlie, una persona mite, con un rapporto civile persino con i poliziotti che lo sorvegliavano. Dal circolo di via Scaldasole, in Porta Ticinese, andò in Fatebenefratelli da solo, tranquillo, sereno, sopra un malandato motorino Benelli, seguendo adagio la 850 blu dei due agenti che l'avevano cercato. Visse in questura ancora tre giorni, prigioniero di un fermo illegale. Nessuna cronaca se ne occupò. Si doveva raccontare di Milano che reagiva al trauma della bomba e si preparava a dire addio ai suoi morti.
CI SALVO' LA ZIA DI VALPREDA
I funerali si celebrarono in Duomo, la mattina di Lunedì 15 dicembre. Centomila in piazza, nel silenzio, sotto un cielo sempre scuro, da buio a mezzogiorno. Fu in quelle ore che la pista anarchica trovò un nome e un volto: Pietro Valpreda. Anche lui uno sconosciuto, che ci venne subito dipinto con tratti tali da indurci a pensare che avessero preso l'uomo giusto. Un bauscione milanese di 37 anni, piccoletto, l'aria dello scalcinato. Un ballerino di mezza tacca, per di più, dissero, azzoppato da una malattia. Un figlio politico di nessuno, con la vita dispersa tra Roma e Milano. Qui aveva qualche amico in Scaldasole e al circolo del Ponte della Ghisolfa, piazzale Lugano, il grigio più grigio della periferia ambrosiana, fabbriche su fabbriche, l'inizio della sopraelevata, il cavalcavia delle Varesine. Infine, uno che straparlava di bombe tanto che il Pinelli l'aveva allontanato.
Se Valpreda era sembrato ambiguo ai suoi compagni, perché avrebbe dovuto apparire limpido a noi dei giornali? Qualcuno lo bollò subito come "il mostro" o "la belva umana". Ma qualcun altro cominciò a riflettere. In pochi, per la verità, ci domandammo com'era possibile che quel Valpreda fosse il perno di un piano complesso, quasi militare, scandito con una sincronia da professionisti della strage. Infatti, le bombe del 12 dicembre erano state cinque. Due a Milano. Tre a Roma. Esplose tutte, tranne una, tra le 16,37, quella in piazza Fontana, e le 17,24. E in luoghi che apparivano scelti apposta per far pensare a terroristi rossi: tre banche e l'Altare della Patria. Un progetto dalla potenza, questo sì, davvero geometrica, come non se n'era mai visti in Italia, neppure nell'agosto delle bombe sui treni. E il tutto affidato ai pochi sgallettati dell'anarchismo ambrosiano-capitolino?
Fu un paradosso a salvarci. Ossia l'immagine scalcagnata che avevamo degli anarchici, noi cronisti nei giornali dei padroni, ma cresciuti in famiglie di operai rossi o di borghesi progressisti. Poi i nostri dubbi divennero più forti per merito di tre persone incontrate in quei giorni. Due erano gli avvocati di Valpreda: Luca Boneschi e Gigi Mariani. Il primo un bel giovane alto, dai modi eleganti e il ragionare calmo. Il secondo più piccolo, di pelo biondo-rosso, cordiale, allegro, un motorino che non si fermava mai. La terza era la prozia di Valpreda: Rachele Torri, allora di 67 anni. Era lei l'alibi di quel nipote sfortunato. Una sera, zia Rachele piombò nella sala stampa della questura, dove bivaccavano gli inviati. Parlò come una forza della natura: "La coscienza, se non si fa viva oggi, si farà viva domani!". La sua sicurezza e la fiducia nell'innocenza di Pietro ci lasciarono sgomenti.
Ma Valpreda era già stato riconosciuto da un tassista milanese, Cornelio Rolandi, 47 anni, convinto di averlo portato verso piazza Fontana nell'ora della strage, con una borsa in mano. Un riconoscimento ben strano, su un'unica foto. A mostrargliela era stato il questore Marcello Guida: "Ci pensi bene. È lui?". E Rolandi: "Sì, forse è lui". E Guida, dandogli un buffetto: "Bravo Rolandi! Hai finito di fare il tassista. Ti sei sistemato", ossia: avrai la taglia di 50 milioni. Erano le 23 di lunedì 15 dicembre. Un'ora dopo, Pinelli volò dal quarto piano della Questura dove stava l'ufficio politico. E piombò dentro un'aiuola stenta, coperta da un velo di neve sporca: la sua tomba.
Quella sera, a lavoro finito, stavo a casa di Corrado Stajano, per mettere a punto il progetto di un libro che poi si sarebbe intitolato "Le bombe di Milano". Era passata da poco la mezzanotte, quando un'ansia strana mi spinse a chiamare l'ufficio della "Stampa", in piazza Cavour. Al telefono venne Gino Mazzoldi, il nostro capo. Ansimava: "Un anarchico è caduto da una finestra della questura. L'ha visto Aldo Palumbo, il cronista dell'"Unità". Pare che l'abbiano portato all'ospedale Fatebenefratelli". Corremmo a chiamare la zia di Stajano: Camilla Cederna. Dormiva, si svegliò, mise un cappotto sulla camicia da notte e corse con noi per capire chi fosse questo anarchico. Era Pinelli, stava morendo sopra la barella, una coperta marrone lo nascondeva quasi per intero. Ci fu impedito di vederlo, e allora ci precipitammo a casa sua. Via Preneste, case popolari d'anteguerra, un luogo povero, i muri scrostati come per una lebbra. Dallo spiraglio della porta, vidi per la prima volta Licia Pinelli, la moglie. Una donna giovane, il bel viso, in una vestaglietta rosa. Mi sembrò dolce e forte. Non ci lasciò entrare in casa. E disse poche parole, senza un tremito, né un pianto. Qualche giorno dopo, la signora Pinelli mi avrebbe spiegato: "Io non piango in pubblico. I miei sentimenti sono soltanto miei".
Da via Preneste andammo in questura. Eravamo in cinque. Davanti a noi il questore Guida, il capo dell'ufficio politico Antonino Allegra, il commissario Luigi Calabresi e il tenente dei carabinieri Sabino Lo Grano. Il questore, un signore di 56 anni, piccolo, rotondo, dall'eloquio torrenziale, ci spiegò che Pinelli aveva deciso di uccidersi quando "si era visto perduto": "Era fortemente indiziato di concorso in strage. Il suo alibi era crollato. È stato un gesto disperato. Una specie di autoaccusa".
E la mattina successiva, Guida rincarò la dose: "Vi giuro che non l'abbiamo ucciso noi! Quando si è accorto che lo Stato stava per incastrarlo, quel poveruomo ha agito come avrei agito io se fossi un anarchico".
A CASA DI LICIA PINELLI
Nessun mistero, dunque. E invece no. La fine di pinelli rese ancora più compatto il grumo di segreti, di bugie e di vendette che stava già acquattato sul fondo limaccioso di piazza Fontana. Con l'andar del tempo, mi sono convinto che il commissario Calabresi non fosse il responsabile di quel delitto, se delitto è stato. Eppure toccò a lui di morire assassinato, dopo la lunga e infame campagna di Lotta continua. Ma anche la fine di Calabresi è ritenuta un mistero. Leonardo Marino ha spiegato tutto, però la sua confessione è al setaccio di un ennesimo processo. Sapere come e perché sia morto Pinelli ci aiuterebbe a capire qualcuna delle tantissime zone buie del piano stragista che scattò il 12 dicembre: un tortuoso fiume di sangue, fitto di anse nascoste, con intrecci che potrebbero risultare strabilianti. Ma proprio per questo temo che la porta rimarrà chiusa.
Poco più di un mese dopo, era la fine del gennaio 1970, andai a intervistare Licia Pinelli. Mi disse: "Mio marito era assolutamente pulito, innocente, e aveva i nervi saldi. Sono convinta che non si è ucciso". Poi concluse: "Io escludo soltanto il suicidio. Per il resto debbono darmi delle spiegazioni. Qualunque fatto sia avvenuto in quella stanza di questura, ci sono delle responsabilità morali. Pino ci è entrato vivo e ne è uscito morto. Devono dirmi il perché". Ad ascoltarci c'erano le due bambine. Claudia masticava una caramella, sgranando gli occhi nel vuoto. Silvia si scioglieva le trecce perché era l'ora del sonno.
Poi andai a trovare Rolandi. Era la sera del 23 gennaio 1970, un altro venerdì. Dalla Lomellina grandi banchi di nebbia scendevano sul quartiere popolare Giorgello di Corsico, alle porte di Milano. Nell'alloggio al dodicesimo piano mi venne incontro un uomo lungo e magro, in pigiama e ciabatte, il volto terreo, gli occhi rossi e acquosi, la fronte imperlata di gelido sudore. Giurava di averlo visto bene, il Valpreda, con la borsa in mano, quella della bomba. Ma borbottava ansando: "Da allora non vivo più, sun cunsciaa da trà via, da buttare via!". Soffriva d'ulcera, di coliti epatiche e di terrori. Mi mostrò piangendo la sua tessera del Pci, numero 0099593, sezione "Garanzini", e il panettone che gli aveva mandato il re Umberto di Savoia. Negò con disperazione d'essersi inventato tutto per incassare la taglia. Poi ebbe nausea, mi pregò di accompagnarlo in bagno. Gli tenni la mano sulla fronte, mentre mi vomitava sui pantaloni. Il portinaio Franco Mora ci osservava perplesso. Poi concluse: "Il Cornelio finirà col morire di paura". Accadde proprio così, il 31 luglio 1971, prima che potesse testimoniare in uno dei tanti processi. Anche Valpreda mi raccontò di aver vomitato, ma per un motivo tutto diverso. Era il novembre 1972 e mi riuscì di incontrarlo quando stava in una stanza-prigione del Policlinico di Roma. Una figura smilza, tuta di lana blu, babbucce rossastre ai piedi. Si muoveva con agilità, le mani sui fianchi.
Mi spiegò che tre anni di sofferenze lo avevano caricato di disperazione e di odio per il sistema e per gli uomini che si era trovato di fronte: "Se non potrò farlo io, ci sarà qualcuno che un domani sputerà sulle loro tombe. Lo Stato mi dà il voltastomaco. Pochi giorni fa mi è successo per davvero: avrò tirato fuori mezzo litro di schifo e di odio. Eccola lì, bella, concreta, reale, la mia valutazione del sistema".
IL LIBRETTO ROSSO DI FREDA
In quel tempo erano già comparsi nell'inchiesta sulla strage le avanguardie del gruppo che tra due mesi andrà sotto processo: Giovanni Ventura e Franco Freda. Nel febbraio 1970 mi aveva messo sulle loro piste una telefonata di Piero Bassetti, poi presidente democristiano della regione Lombardia: "Dalle parti di Treviso, un nostro segretario di sezione dice di aver saputo che le bombe del 12 dicembre le hanno messe i fascisti. Vai dall'onorevole De Poli: è l'avvocato di questo testimone". Ronchey mi fece partire subito e così conobbi Guido Lorenzon. Da lui risalii a quei due sconosciuti.
Ventura aveva 26 anni, lo ricordo grande e grosso, il passo ampio e un po' lento, gli occhi a biglia spaventati. Nel suo magazzino librario ringhiò: "Lorenzon è pazzo. Ha inventato tutto". Freda, 29 anni, faceva il procuratore legale, ma lo rammento in uno studiolo padovano vuoto di pratiche. Aveva un volto bello e crudele, da comparsa della "Caduta degli dei", il film di Luchino Visconti sul nazismo. Non mi parve impaurito, anzi sembrava un tigre pronto ad azzannare. Mi mostrò un libretto rosso, diceva che era roba maoista. In realtà l'aveva sfornato lui o qualcuno dei suoi camerati. Sulla copertina una frase di Lao-tze, profetica: "La giustizia è come il timone: dove la si gira, va". Andò davvero così. Trent'anni di attesa e nessun colpevole. Chi l'aveva previsto era Guido Calvi, l'avvocato romano di Valpreda. Quando lo conobbi, nell'ottobre 1972, aveva solo 32 anni, ma era già saggio. Mi disse: "Il processo non ci offrirà mai la verità su piazza Fontana, ma ci darà quella sulle deviazioni istruttorie, sulla manipolazione del quadro probatorio, sulla connivenza di politici e burocrati con l'eversione fascista. Insomma, ci regalerà uno spaccato delle nostre istituzioni, ci dirà a quale punto siano deteriorate, e che cosa domani potrebbe accadere a ciascuno di noi, perché qui c'è un tumore che si riproduce. Per questo, sarà molto più facile scarcerare Valpreda che fare il processo". È quel che è avvenuto. Adesso speriamo nel giudizio che si aprirà a Milano il 16 febbraio dell'anno 2000..
12 novembre 1995 - La lite tra i giudici
Non desiderare la spia d’altri
di Antonio Carlucci
Hai depistato l'inchiesta d'accordo col Sismi, accusa il pm di Venezia. Hai cancellato anni di indagini, replica il gip di Milano. E il conflitto tra i due magistrati finisce in Parlamento. Chi ha ragione?
Massimo Brutti e Giovanni Pellegrino, senatori pidiessini, entrambi a capo di una commissione parlamentare (rispettivamente Servizi segreti e Stragi), dovranno presto affrontare la contesa che divide due magistrati. Si tratta di Guido Salvini di Milano e Felice Casson di Venezia. Il primo ha accusato il secondo di essere "incorso in un madornale errore di valutazione" e di aver arrecato un danno irreparabile all'inchiesta sulla strage di piazza Fontana (Milano, 12 dicembre 1969, 16 morti e 84 feriti) e a quella sull'organizzazione terrorista neofascista responsabile di anni di bombe e terrore.
Casson ha ribaltato l'accusa. In una lettera alle commissioni ha disegnato a tinte fosche un'operazione dei carabinieri del Ros e del Sismi, diretta e coordinata da Salvini, per convincere un ex terrorista di destra a collaborare alle indagini e poi remunerarlo. E bollandola come un depistaggio messo a segno dai servizi, ha sollevato seri dubbi sul comportamento del collega. Casson è il magistrato che ha portato alla luce la verità sulla strage di Peteano (tre carabinieri dilaniati da un'auto bomba) e, soprattutto, sulle protezioni che alti ufficiali dei carabinieri operarono nei confronti della cellula terrorista responsabile del crimine. Negli ultimi anni, poi, ha inseguito le possibili deviazioni di Gladio, l'organizzazione militare clandestina alleata, entrando in conflitto con l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, strenuo difensore della legalità di Gladio. Salvini, giudice istruttore a Milano, è diventato noto con l'inchiesta sulla morte di Sergio Ramelli, un neofascista ucciso a bastonate da estremisti di sinistra che sono stati individuati, processati e condannati molti anni dopo i fatti.
Poi, sul suo tavolo era giunto il fascicolo su Piazza Fontana, la vicenda che tra mille indagini, molti processi, tante interferenze, è approdata al nulla giudiziario. Per anni ha lavorato in silenzio e nella primavera del 1995, con il dossier che riguarda i reati associativi commessi dai neofascisti di quell'epoca, è stato possibile capire che la verità su esecutori e mandanti può essere molto vicina. Da quelle carte apparve anche più chiaro come le cellule neofasciste di Ordine nuovo fossero imbottite di persone arruolate dai servizi segreti americani.
Casson fu tra i primi a commentare favorevolmente i risultati di Salvini. Tanto sembrava vicina la verità su Piazza Fontana, che quel troncone di indagine fu rispedito alla procura e rivitalizzato con l'applicazione del nuovo codice che impone, tra le altre cose, tempi più rapidi nella conclusione.
Nell'ufficio di Salvini, ancora sottoposti al vecchio codice, restarono tutti gli episodi preparatori, la banda armata che aveva operato in Italia e lo spionaggio relativo al ruolo degli agenti segreti della Cia e degli italiani che, pur essendo militanti di Ordine nuovo, passarono ogni informazione sulle attività terroristiche ai servizi segreti americani. Ora, però, i due magistrati sono entrati in aperta rotta di collisione.
La data della svolta è giovedì 19 ottobre scorso. Quel giorno Casson ha iscritto sul registro degli indagati Massimo Giraudo, un ufficiale dei carabinieri che lavora presso il Ros, il reparto specializzato nella lotta alla criminalità e all'eversione. Il capitano Giraudo è finito nel mirino del giudice veneziano per i contatti avuti con Martino Siciliano, un neofascista che ha deciso di raccontare la sua esperienza in Ordine nuovo dal 1965 al 1973. Ma alla storia di Siciliano e dell'ufficiale Casson non è arrivato direttamente, ma in base alle lamentele di un altro neofascista, il medico ultrasessantenne Carlo Maria Maggi (era il responsabile in Veneto di Ordine nuovo e ha sulle spalle una condanna definitiva per ricostituzione del partito fascista e detenzione di armi ed esplosivi). Maggi, sotto inchiesta a Milano per le vicende collegate con la bomba di Piazza Fontana, presentò un esposto nell'estate del 1995. Disse di essere "perseguitato" dai carabinieri del Ros che gli chiedevano con insistenza di mollare il suo passato e collaborare alle indagini. Maggi accennò nella denuncia a offerte di denaro. Quell'esposto finì anche al ministero della Giustizia. L'obiettivo di Maggi era intralciare, se non bloccare, il lavoro di Salvini: da mesi tutti gli appartenenti alle cellule terroristiche del Veneto sapevano che il magistrato di Milano aveva fatto passi avanti: intuivano che tra di loro molti avevano deciso di collaborare e che nelle carte degli investigatori non c'era solo la mappa precisa dell'organizzazione, ma nomi e cognomi dei responsabili degli attentati, compreso quelli del commando che aveva operato a Piazza Fontana. Maggi svelò le sue segre- te intenzioni nel corso di una telefonata a un amico: sperava che la sua denuncia mettesse in moto l'ennesima ispezione presso gli uffici giudiziari milanesi, un'ipotesi alimentata da quello che accadeva in quelle settimane per le iniziative dell'ex ministro Filippo Maria Mancuso. Forse, non pensava affatto che sarebbe stato proprio uno dei magistrati che più accanitamente avevano perseguito i neofascisti veneti ad aiutarlo contro il magistrato milanese.
La denuncia, infatti, finì anche sul tavolo di Casson. Il magistrato cominciò a indagare, seppe incidentalmente che un altro neofascista era stato avvicinato all'estero, e che, al contrario di Maggi, aveva accettato di collaborare e aveva ottenuto un compenso per cambiare continente grazie ai fondi del Sismi. Il binomio neofascisti-servizi segreti creò un corto circuito: a Casson tornarono in mente antichi scenari di rapporti poco chiari tra 007 e destra eversiva.
Senza chiedere lumi a Salvini, Casson agì subito in due direzioni: si presentò a Forte Braschi chiedendo il dossier Siciliano e convocò l'ufficiale del Ros al quale chiese di raccontare la storia. Risultato: dagli archivi del Sismi portò via carte e lettere, l'incontro con il capitano dei carabinieri che aveva spiegato senza reticenze ogni passo della storia ebbe come coda l'iscrizione dell'ufficiale nel registro degli indagati. Infine, con la lettera alla Commissione sui servizi, bollò l'intera vicenda di depistaggio e deviazione dei servizi. Salvini, che ha sempre giudicato ogni indiscrezione sulle indagini come un'irresponsabile interferenza (atteggiamento di assoluta riservatezza che non riguarda solo i giornalisti ma anche i suoi colleghi magistrati), ha reagito subito con una nota di impressionante durezza in cui punta il dito contro Casson: "Solo a istruttoria conclusa, l'opinione pubblica e i familiari delle vittime potranno comprendere quali danni l'abbaglio colossale preso dal pubblico ministero di Venezia ha causato alle indagini in corso". E ancora: "Sulla mancanza di professionalità e di riservatezza di un'autorità giudiziaria ricade la responsabilità di essere caduta in un tranello del genere, muovendosi al di fuori di ogni competenza e senza minimamente conoscere le centinaia di atti istruttori e accertamenti svolti...".
Se questa fu la prima reazione, la seconda non è stata da meno. Nella lettera ai due parlamentari presidenti di commissione, Salvini ha tenuto fermi i duri giudizi contro Casson. Poi ha ricostruito minuziosamente la storia di Martino Siciliano, del suo coinvolgimento nella strage, del suo aggancio, dei tentativi dei camerati di un tempo di convincerlo a restare zitto (fu invitato a una riunione a San Pietroburgo dove gli fu esposta ogni possibilità di aiuto), della decisione di collaborare. Salvini ha chiuso la sua relazione riferendo, sommariamente ma con precisione, il contributo che l'ex ordinovista ha fornito. Ma sono le ultime 23 righe delle otto pagine scritte dal giudice di Milano, la benzina che alimenterà per molto tempo questo fuoco. Se Casson ha definito la vicenda una deviazione e un depistaggio in cui a farla da protagonisti sono i servizi segreti militari, Salvini ha scritto queste parole: "A partire dal 1992, il contributo del Sismi è da considerarsi pieno e prezioso... Grazie al contributo del Sismi è stato possibile localizzare altri soggetti residenti in paesi lontani e altrimenti non localizzabili. Un completo cambiamento di rotta, quindi, rispetto alle "deviazioni" del vecchio Sid, condotto con serietà e discrezione e che non deve essere interrotto da iniziative di mera pubblicità"..
1 2 3
Pagina 3 di 3
(12 Novembre 1995)
|
L'UNITA'
per l'articolo completo vai al sito Internet
http://www.unita.it
2009-12-12

Piazza Fontana, Napolitano: "Recuperare qualsiasi frammento di verità nascosto": Fischi alla Moratti
Bisogna continuare a cercare la verità. E' l'appello di Giorgio Napolitano alle istituzioni, ai giudici e ai familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana, che oggi viene commemorata a Milano, in occasione del 40° anniversario. Tensione nei due cortei che hanno attraversato Milano: contestati con fischi e urla il sindaco di Milano Letizia Moratti, il presidente della Provincia Guido Podestà e il presidente della Regione Roberto Formigoni. I manifestanti dei centri sociali hanno cercato di sfondare i cordoni di polizia per entrare in piazza Fontana; lanci di petardi e fumogeni, alcune transenne sono state abbattute.
"Continuate pure a cercare perché si possa recuperare qualsiasi frammento di verità rimasto nascosto. Spero che questa vostra ricerca, a cui debbono collaborare tutte le istituzioni, possa condurre a dei risultati. E' essenziale che quello che avete vissuto, quello che è accaduto nel nostro Paese, diventi parte di una consapevolezza storica, soprattutto per le nuove generazioni", ha scritto il presidente ai familiari delle vittime.
Due i cortei per celebrare il quarantennale di piazza Fontana. Il primo aperto da una delegazione dei familiari delle vittime e dai gonfaloni di numerose città, primo tra tutti quello di Milano dietro il quale sfila anche il sindaco Letizia Moratti, che però è stata duramente contestata nel corso del suo intervento. Dal pubblico sono arrivati infatti fischi, e anche parecchi "Vergogna, vergogna!".
Il secondo corteo è organizzato da Prc, Comunisti Italiani e diverse organizzazioni della sinistra e anarchiche. Le due manifestazioni si concluderanno a distanza ravvicinata.
"Chi ha ostacolato con una selva di fischi gli interventi delle Autorità durante la commemorazione delle vittime non ha rispettato il dolore dei familiari e si è di fatto schierato con quanti non accettano che vengano alla luce chiarezza e giustizia sulla Strage di Piazza Fontana". Queste le parole del presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà, in merito alla contestazione di oggi durante la commemorazione delle vittime di Piazza Fontana.
"I contestatori, che io considero professionisti del disordine, hanno, quindi, dimostrato con il loro comportamento di non comprendere i valori di questa manifestazione giunta al suo quarantennale. Il clima di intolleranza respirato oggi ricorda, purtroppo, per molti versi quello in cui maturò la Strage di Piazza Fontana. Questa è la base sulla quale poter costruire un confronto democratico che contribuisca a ricostruire la verità finora negata".
12 dicembre 2009
Napolitano: "Recuperare qualsiasi frammento di verità nascosto"
Un messaggio di incitamento ai familiari delle vittime, un richiamo molto attuale all'unità del paese intorno alla Costituzione. Così il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione della cerimonia commemorativa del 40B0 anniversario della strage di Piazza Fontana, si è rivolto a tutti i partecipanti: "Vi giungano i sentimenti della mia solidarietà, della mia vicinanza istituzionale e umana, del mio apprezzamento e del mio incitamento in nome dell'Italia unita attorno alla Costituzione repubblicana".
Il Presidente Napolitano ha chiesto alla signora Francesca Dendena, Presidente dell'Associazione Familiari delle vittime della
strage di Piazza Fontana, e al prof. Carlo Smuraglia, Presidente del Comitato permanente antifascista contro il terrorismo per la difesa dell'ordine repubblicano, di rendere partecipi gli intervenuti alla manifestazione del messaggio rivolto ai familiari delle vittime e ai rappresentanti delle Associazione nell'incontro del 7 dicembre a Milano: "Il chiedere giustizia per le vittime del terrorismo, per tutti coloro che hanno pagato, non significa solo chiedere riparazione ai tribunali ma chiedere giustizia e riparazione alla nazione. Dobbiamo riuscire a gettare le basi di una vita democratica per il nostro paese, che non corra più i rischi
terribili, che non conosca più le fratture terribili che ha vissuto alcuni decenni orsono.
Questo ci dice la strage di Piazza Fontana, questo ci dice una lunga e tormentata vicenda di indagini e di processi da cui non si è riusciti a far scaturire una esauriente verità giudiziaria. Il nostro Stato democratico porta su di sè questo peso, con cui deve fare i
conti la coscienza di tutti gli italiani. Alle famiglie delle vittime di Piazza Fontana e alle Associazioni che le hanno sostenute dico: vi rinnovo la mia ammirazione per come avete per quarant'anni continuato a vivere la sofferenza del primo momento; è stato molto duro e non avete mai accettato di chiudere la parentesi, non avete mai accettato di ritornare nemmeno soltanto nel vostro privato dolore e nel vostro privato ricordo.
La mia ammirazione per la tenacia, per la passione civile, per la forza di volontà con cui avete continuato a alimentare una memoria collettiva, non soltanto memorie personali e private, e a proporre temi di riflessione. Memoria e riflessione: sono questi i due impegni a cui voi non avete abdicato, e a cui l'Italia e la coscienza nazionale non possono abdicare. Memoria, per capire quello che è accaduto; memoria, anche per cercare di andare oltre. Continuate pure a cercare perchè si possa recuperare qualsiasi frammento di verità rimasto nascosto. Spero che questa vostra ricerca, a cui debbono collaborare tutte le istituzioni, possa condurre a dei risultati.
È essenziale che quello che avete vissuto, quello che è accaduto nel nostro paese, diventi parte di una consapevolezza storica, soprattutto per le nuove generazioni. Sono passati quarant'anni, e ci sono persone adulte, non solo dei giovani o dei giovanissimi, che non hanno vissuto e fanno fatica anche soltanto a rivivere nella memoria o nella storia quelle vicende. Questo è uno dei compiti che voi avete assunto, ed è giusto che lo portiate avanti".
12 dicembre 2009
Una bomba per fermare la storia col sangue
di Oreste Pivettatutti gli articoli dell'autore
Gli italiani appresero della bomba dal telegiornale della sera, Rauno. A Milano si sapeva: dapprima la caldaia che era esplosa, abbastanza presto dell’attentato. Appena dopo che erano stati i "comunisti", ma subito prese a girare una raccomandazione: "Bisogna chiedersi a chi giova". Il senso comune stava già aggiustando le cose. La Rai non aveva pensato a edizioni straordinarie. Aveva richiamato un operatore da Bolzano e l’aveva spedito in piazza Fontana, alla Banca dell’Agricoltura. Fu lui a riferire in redazione: "Altro che caldaia. Una caldaia al tritolo". Glielo aveva sussurrato un ufficiale della Digos.
Dallo schermo in bianco e nero Rodolfo Brancoli cominciò a raccontare di tredici morti e settantotto feriti, di un buco largo un metro nel pavimento e delle assicurazioni del ministro dell’Interno Restivo: che si sarebbe fatto tutto il possibile per trovare i colpevoli. Già Brancoli chiarì: la caldaia era rimasta intatta, non ci sono dubbi che ci sia stata una bomba. Brancoli informò anche delle tre bombe di Roma, all’Altare della Patria, all’ingresso del museo del Risorgimento, nel sotterraneo della Banca nazionale del lavoro. Pochi minuti e chiuse: "Colleghiamoci con Milano, con Elio Sparano". E finalmente, oltre la voce grave di Elio Sparano, le immagini: dentro la banca le macerie, gli infissi divelti, i vetri infranti e il buco; fuori la gente al di là delle transenne nel buio di una serata fredda, nebbiosa, uggiosa. Sparano confermò: tritolo, sette otto chili, tredici morti… Poi gli ospedali: i feriti, bendati, fasciati, che dai loro letti sembravano guardare nel vuoto, incapaci a capire. Infine si seppe di un’altra bomba, collocata in una valigetta davanti alla Banca commerciale, poco lontano. Quella venne fatta esplodere per ordine del procuratore capo Enrico De Peppo: così si persero possibili tracce. A Mario Pastore toccò il pastone politico, cominciando dal messaggio del presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat. Dall’inizio alla fine in sei minuti e mezzo. La bomba era esplosa alle 16,37 del 12 dicembre, un venerdì pomeriggio. La Banca dell’Agricoltura era aperta, come non capitava per le altre banche: era un luogo di contrattazione e lì si ritrovavano commercianti e produttori per discutere di affari. Poco più in là, verso corso Vittorio Emanuele e piazza del Duomo, s’erano accese le luminarie di Natale. Le strade erano affollate. Lo scoppio si sentì anche lontano. Alla Statale gli studenti del movimento erano riuniti in assemblea. Qualcuno cercò di sapere che cosa fosse mai successo. Tornò in aula e riferì. Mario Capanna, il leader, invitò tutti a lasciare l’università e a tornare a casa in piccoli gruppi, senza dar nell’occhio: temeva provocazioni fasciste. Lo scoppio lo avvertì anche Ugo Paolillo, il pubblico ministero di turno. Paolillo avrebbe iniziato con scrupolo l’indagine, che però gli venne sottratta e subito trasferita a Roma, nonostante il giudice naturale fosse quello di Milano. Paolillo s’era avviato da casa in via Corridoni verso il Palazzo di giustizia. Arrivando, trovò una macchina pronta a condurlo in piazza Fontana. Là c’era già il sottufficiale di pubblica sicurezza Michele Priore. Viaggiava sull’autobus N, che faceva fermata pochi metri in là rispetto all’ingresso della banca. L’autobus dovette fermarsi, lui scese e si precipitò nel salone devastato. "Ai primi accorsi l’interno della banca offriva un raccapricciante spettacolo: sul pavimento, che recava al centro un grande squarcio, giacevano, tra calcinacci e resti di suppellettili, vari corpi senza vita ed orrendamente mutilati, mentre persone sanguinanti urlavano il loro terrore…": così sta scritto nella sentenza di primo grado, la sentenza di Catanzaro, il 23 febbraio 1979, quella che condannò all’ergastolo per strage i fascisti Freda e Ventura e Guido Giannettini, il giornalista che era diventato con il nome in codice "Zeta" un agente del Sid, il servizio italiano di spionaggio. Il giorno dopo sarà il giorno dello sgomento, della paura, delle domande. Il telegiornale ne raccolse qualcuna tra la gente, al microfono di Romano Battaglia. La telecamera percorse i corridoi e gli stanzoni degli ospedali soffermandosi sul viso dolce di un bimbo: Enrico Pizzamiglio, tredici anni, che perse una gamba. Alla fine i morti furono diciassette: quattordici subito, altri due in ospedale, un altro morto si aggiunse un anno dopo, per le conseguenze delle ferite. Passati quarant’anni, anche lo Stato italiano riconobbe la diciottesima vittima: Giuseppe Pinelli, che tre giorni dopo la strage volò dalla finestra della Questura. "Morte accidentale di un anarchico", scrisse Dario Fo. Il telegiornale comunicò: "Giuseppe Pinelli stanotte veniva interrogato in una stanza al quarto piano della Questura. Durante una breve sosta dell’interrogatorio si è gettato nel vuoto da una finestra rimasta socchiusa, nonostante il tentativo di trattenerlo da parte del personale di polizia presente in quel momento… è caduto in questa aiuola…". La telecamera inquadrò il selciato e alcune pianticelle spezzate.
Tra le immagini degli archivi Rai anche quelle (mai andate in onda) della prima conferenza stampa di Marcello Guida, il questore che era stato durante il fascismo direttore delle guardie a Ventotene, l’isola degli antifascisti al confino. Sullo sfondo il quadro di un paesaggio invernale. Guida, panciuto con i capelli impomatati, come due funzionati che gli stavano accanto, assicurò i giornalisti che le indagini sarebbero state condotte nel migliore dei modi. Sorrideva sempre, come i due colleghi, come avesse dovuto raccontare una favoletta. La seconda conferenza stampa, indimenticabile, Guida la tenne la notte dopo la morte di Pinelli, davanti a cinque giornalisti (tra i quali la nostra Renata Bottarelli), con toni da aperitivo in salotto, fino alle tre del mattino. In sostanza, come racconta Corrado Stajano, altro testimone, disse di Pinelli: "Aveva gli alibi caduti. Un funzionario gli aveva rivolto contestazioni e lui era sbiancato in volto". "Un pezzo da antologia – scrisse Ibio Paolucci nel suo libro Il processo infame – per chi voglia insegnare a distinguere, in un resoconto ufficiale, le menzogne più sfacciate dalla verità…". La strada era stata però aperta dal ministro Restivo, in un telegramma alle polizie europee: non abbiamo nulla in mano, "ma dirigiamo le nostre supposizioni verso i circoli anarchici". Così toccò pure a Pietro Valpreda, proprio il 15 dicembre, riconosciuto come l’uomo della valigetta dal tassista Cornelio Rolandi, "che abita a Corsico", Il giorno dopo Valpreda sarebbe diventato il "mostro". Lo annunciò Bruno Vespa: "Pietro Valpreda è un colpevole…". Valpreda divenne il mostro sulle prime pagine di quasi tutti i giornali. L’Unità fu più prudente: "Ancora una fitta rete di misteri". Qualcuno si spinse in là: "Sono stati i comunisti". Un salto logico, ideologico, stupefacente. Non bastavano gli anarchici. Tutto quel venerdì 15 dicembre, anche i funerali in Duomo, con il cardinale Giovanni Colombo e il presidente del Consiglio Mariano Rumor, tanta gente, trecentomila persone e le sedici bare allineate, tanta gente e sopra la nebbia... In piazza era già stato alzato l’albero di Natale. Da quel giorno per quarant’anni, e non è ancora finita, davanti a giudici e tribunali sono sfilati i personaggi più diversi e insospettabili: esaltati manovali del crimine, generali e colonnelli, da Miceli a Maletti, capi del Sid, al capitano Labruna, che aveva favorito la fuga di Giannettini, e tanti ministri, da Andreotti a Rumor a Mario Tanassi. Valpreda fu del tutto discolpato. Per Pinelli non vi fu mai incrimazione. Si capì che la bomba avrebbe dovuto seminare il panico nel paese e provocare tensioni, scontri, violenze, giustificando l’intervento repressivo. Entrò in ballo anche la Cia. Il modello era la Grecia. Si capì che lo Stato occultava, copriva, tollerava, aiutava e si giunse però a una verità storica: che l’officina delle bombe era di estrema destra, la destra dei fascisti di Ordine nuovo, quello fondato da Pino Rauti.
12 dicembre 2009
In redazione con Natta, Cossutta e Pajetta
di Ibio Paoluccitutti gli articoli dell'autore
Il 12 dicembre del 1969, nelle prime ore del pomeriggio, mi trovavo a Roma in buona compagnia in una saletta del terzo piano del Palazzo dell’Unità, in via Taurini, per partecipare ad una riunione del Consiglio di amministrazione del quotidiano, di cui facevo parte, in rappresentanza dei giornalisti delle redazioni del Nord. La riunione era iniziata da un’oretta quando un compagno venne ad avvisarci dello scoppio a Milano alla Banca nazionale dell’agricoltura di piazza Fontana, precisando però che le agenzie parlavano dell’esplosione di una caldaia. Alla riunione partecipavano Armando Cossutta, Giancarlo Pajetta, Alessandro Natta e Anelito Barontini. Il primo, membro della segreteria nazionale del Pci, presiedeva anche alle questioni amministrative. Natta era il direttore di "Rinascita", Pajetta dell’Unità e Barontini era l’amministratore del Partito. Tranquillizzati dalle prime notizie dell’Ansa, continuammo la riunione, che, però, si interruppe di nuovo e questa volta definitivamente dopo una ventina di minuti. Arrivò, infatti, lo stesso giornalista per comunicarci che purtroppo si trattava di una bomba che aveva provocato un grosso numero di morti e di feriti. Facce preoccupate e sgomente dei dirigenti, con Natta che disse "Bisogna avvertire Berlinguer, ci penso io". Io, come "esperto" milanese, fui incaricato di passare i pezzi che venivano da Milano. La prima domanda dei compagni romani fu di sapere dove si trovava questa piazza Fontana. Fece molta impressione quando precisai che si trovava a pochi passi dal Duomo. Colpito il cuore di Milano e, dunque, dell’Italia. A me toccò leggere chilometri delle agenzie Ansa e Italia e di passare poi in tipografia un lungo articolo di Fernando Strambaci, come sempre molto dettagliato e preciso, e altri pezzi. Mi raggiunse anche una telefonata da Milano per farmi sapere che i funerali delle vittime ci sarebbero stati lunedì e che io avrei dovuto farne la cronaca.
Giornata gelida e grigia quella del lunedì 15 dicembre. Le bare allineate nel Duomo e, fuori, i lampioni accesi per forare la nebbia. Freddissimo sul sagrato, strapieno di operai e di studenti. Decine e decine di migliaia. Così si dissolse la fortissima preoccupazione di incidenti. Erano ancora nell’aria i funerali dell’agente di polizia, Annarumma, durante i quali violente e accese erano state le urla dei fascisti. Mario Capanna, presentatosi ai funerali in via Fatebenefratelli, aveva rischiato il linciaggio. Uscito di casa, presi la metro alla vicina stazione di Lima. Arrivavano i convogli da Sesto san Giovanni, dalle grandi fabbriche, dalla Marelli, dalla Falck, ed erano strapieni di operai in tuta. I treni pieni come un uovo non si fermavano. Dovetti aspettare un bel po’ prima di salire su uno di essi e quando riuscii a farlo mi trovai pigiato contro spalle e petti di operai. Poche le fermate per arrivare al Duomo, lungo il corteo degli operai che ne scendevano. I treni ripartivano da quella stazione completamente vuoti. Giunto nella piazza tirai un altro grosso sospiro di sollievo. Vidi subito, infatti, che assieme agli operai c’erano tantissimi studenti. Erano loro che dominavano incontrastati la piazza. In quella muraglia operaia mi ci tuffai dentro con in mano, quasi brandendola come una bandiera, l’Unità. Compagno fra compagni, ma anche cronista. Mi trovai accanto colleghi dei giornali che allora chiamavamo "borghesi" e che, diciamo la verità, guardavamo, noi dell’Unità, un po’ dall’alto in basso. Molti di loro, però, erano giornalisti che stimavamo e con i quali, sul fronte dell’antifascismo e della strategia della tensione, avevamo combattuto tante battaglie. Ricordo, fra gli altri, Marco Nozza, Corrado Stajano, Gianpaolo Pansa, Marcellina Andreoli, Giulio Obici, Giorgio Manzini. Quella mattina di lunedì pochissimi conoscevano i nomi di Pinelli e di Pietro Valpreda, arrestato proprio quel giorno in un corridoio del Palazzo di Giustizia di Milano. E nessuno sapeva che quella stessa sera, verso la mezzanotte, Pinelli sarebbe precipitato da una finestra del quarto piano della Questura, nel corso di un interrogatorio, trattenuto illegalmente. E nessuno, quella mattina, neppure il titolare dell’inchiesta sulla strage, che era il Pm Ugo Paolillo, sapeva che la Procura di Milano sarebbe stata estromessa dalle indagini. Sarebbe cominciato l’indomani un lunghissimo, drammatico capitolo. Il processo per la strage venne celebrato in primo grado e in appello nella sede di Catanzaro, lontana oltre mille chilometri dal suo giudice naturale, che era, incontestabilmente, Milano. Ma allora queste decisioni potevano essere prese dalla Corte di Cassazione, che, anzi, aveva ordinato di trasferire in quel capoluogo calabrese anche l’inchiesta istruttoria in corso a Milano, proprio quando, alla vigilia di Natale del 1974, i magistrati erano sul punto di accertare la verità. Inutilmente il Pm Emilio Alessandrini trascorse una intera notte nel palazzo di Giustizia per scrivere la richiesta al giudice istruttore Gerardo D’Ambrosio di rinviare a giudizio Freda, Ventura e Giannettini per il reato di strage. D’Ambrosio accolse quella richiesta, ma la suprema corte la negò. In compenso i magistrati di Catanzaro ritennero invece valido l’impianto accusatorio dei colleghi milanesi. E’ da ricordare al riguardo che il Pm Alessandrini, che sarà assassinato il 29 gennaio del 1979 dai terroristi di Prima linea, aveva scritto nella requisitoria che la strage era stata compiuta con la complicità dei servizi segreti, di cui Giannettini, in stretto contatto con Freda e Ventura, era un collaboratore. La sentenza di primo grado si concluse con le condanne all’ergastolo di Freda, Ventura e Giannettini e con la assoluzione di Valpreda per insufficienza di prove. Alle prime condanne alla massima pena, seguirono in appello generali assoluzioni, sia pure con la formula del dubbio. La Cassazione rinviò il giudizio alla corte di appello di Bari, stralciando però la posizione di Giannettini, per il quale confermò l’assoluzione, privando, in tal modo, i giudici pugliesi di un approfondimento su un punto decisivo del processo. Fu così che mentre il Sostituto Procuratore generale chiedeva la condanna di Freda e Ventura, la Corte d’Appello di Bari confermò invece le assoluzioni. Tornato il processo alla Cassazione si ebbe per i due imputati l’assoluzione. La sola condanna rimase per il generale Gianadelio Maletti e per il capitano Antonio La Bruna per le protezioni e i documenti falsi concessi a Giannettini e a Pozzan. Per finire, non sarà privo di interesse ricordare le reticenti testimonianze di Tanassi e Rumor, rispettivamente ex ministro della difesa ed ex presidente del consiglio, che, interrogati dai giudici del primo grado sulle coperture concesse dal Sid a Giannettini, infiorettarono le loro risposte con continui "non ricordo". Lo stesso comportamento, peraltro, fu adottato anche dall’allora primo ministro Giulio Andreotti. Tutti smemorati i ministri del governo democristiano del tempo..
12 dicembre 2009
"I fascisti ora parlano. Un nuovo processo per la verità completa"
di Rinaldo Gianolatutti gli articoli dell'autore
Quarant’anni, il tempo della storia. Il dovere della memoria è faticoso anche se doveroso per le vittime di piazza Fontana e Pino Pinelli. Ma in quest’Italia sfilacciata e proterva, la storia e il ricordo rischiano di apparire solo una consolazione personale, individuale, in un paese che tutto dimentica perchè la condivisione del passato, di ogni passato, non è ancora una conquista collettiva e chissà se mai lo sarà. Federico Sinicato è l’avvocato delle famiglie delle vittime di piazza Fontana e rappresenta la Camera del Lavoro di Brescia nel processo in corso per la strage di piazza della Loggia. Il suo impegno e la sua battaglia nelle aule dei tribunali aiutano a non abbassare la guardia, a cercare la verità, anche oggi.
Piazza Fontana: dopo tanti anni nessuno è in galera per quella strage. Ci rimane solo la memoria, forse è un po’ poco.
"No. Io penso e ripeto che la memoria di quella strage sia un elemento fondante della nostra storia. Piazza Fontana ha un valore profondo nella coscienza democratica del paese, è uno snodo essenziale. Non lo si può superare saltandolo, bisogna affrontarlo e risolverlo come fanno tutti i paesi davanti alla grandi tragedie. Le generazioni di ragazzi di allora sono diventate adulte con piazza Fontana accanto, destra e sinistra sono cresciute nella diffidenza reciproca, profonda per quel fatto. O sciogliamo tutti insieme quel nodo e scriviamo una storia condivisa, accettata da tutti e così l’Italia può superare questo quarantennio oppure si protrarrà la divisione. Non ci sono alternative. Piazza Fontana ha lo stesso valore della lotta di Liberazione, ci sono voluti decenni perchè il paese acquisisse la Resistenza come fondamento della Repubblica. La memoria è importante. Conta di più, però, sciogliere i nodi".
Sul 12 dicembre c’è un nodo storico-giudiziario: chi mise la bomba. E un altro politico: perchè lo stragismo divenne un fattore costante per vent’anni nella vita della nostra Repubblica. A che punto siamo?
"Sotto il profilo storico-giudiziario siamo vicini alla fine. Le diverse indagini realizzate e i vari processi celebrati hanno raccolto molto, ormai sappiamo tanto sulla destra eversiva, sui suoi rapporti con i servizi segreti e le istituzioni, conosciamo le persone che facevano parte di quella politica stragista. I responsabili della bomba di piazza Fontana sono Franco Freda e Giovanni Ventura. Anche se non sono in carcere, anche se non potranno più essere giudicati, sono i responsabili della strage. C’è scritto anche nelle sentenze dei processi che hanno assolto altri imputati. Carlo Digilio si salva con la prescrizione, ma è riconosciuta la sua responsabilità".
Cosa ci manca, allora?
"Ci è mancata una costruzione più rigorosa del coacervo di prove contro Ordine Nuovo, la prova regina che dipendeva da Carlo Digilio si è sgretolata in alcuni punti. Non si sono trovati i riscontri. Penso che il giudice Salvini sia stato lasciato troppo solo nel suo lavoro e questo ha reso più debole la conclusione".
E il nodo politico?
"Dal punto di vista politico ci sono delle novità che vale la pena considerare. Oggi ci sono esponenti dell’area della destra eversiva che hanno iniziato a parlare, disposti a raccontare quei fatti. Sono passati tanti anni, molti sono invecchiati, qualcuno ha cambiato idea e analizzato criticamente il suo passato. Al processo di Brescia anche i fascisti parlano, c’è una maggiore disponibilità. A Brescia i testimoni sono i protagonisti dei processi delle stragi: abbiamo sentito come erano organizzati i fascisti di piazza San Babila, dove tenevano le armi, chi li chiamava, conosciamo nuovi dettagli dei rapporti tra la destra eversiva con i servizi segreti nel 1969 e anche prima, sappiamo dei depistaggi. Penso che possiamo chiudere il quadro".
Cosa c’è di nuovo?
"Alcuni fatti, qualche testimonianza. Gianni Casalini, già collaboratore di Freda e Ventura, sembra pronto a pulirsi la coscienza, ha ammesso alcuni episodi di cui è stato protagonista e testimone. Negli anni Settanta Casalini era un importante informatore del Sid, a un certo punto Maletti decise velocemente di chiudere quella " fonte" perchè sospettava che Casalini potesse svelare troppi segreti. Sarebbe molto interessante se Casalini svelasse cosa sapeva e perchè Maletti decise all’improvviso di allontanarlo".
E poi, come si prosegue?
"Partendo da Casalini sono state identificate altre due persone componenti il gruppo di fuoco di Freda e Ventura. Uno si chiama Ivano Toniolo, già indagato nell’ambito della pista veneta, poi prosciolto, ora vive in Africa. Un’altra traccia è il ritrovamento dell’agenda di Ventura, sequestrata all’epoca e poi "dimenticata" in uno scantinato a Catanzaro al tempo del processo. Nell’agenda sono segnate le visite di Ventura a Paese, comune in provincia di Treviso, dove aveva un piccolo casolare in affitto per custodire l’esplosivo. La notizia del casolare era già stata segnalata da Digilio, ma forse non venne creduto. Invece oggi possiamo affermare che Ventura usava quel posto e un altro teste ha confermato la circostanza".
Tutto questo giustifica un altro processo per piazza Fontana?
"Sono elementi importanti, ci sono prove a carico di persone fisiche. Freda e Ventura non possono più essere giudicati, ma un giudizio per altre persone coinvolte nello stragismo potrebbe essere decisivo per arrivare a una completa verità. Siamo in una fase preliminare, toccherà alla Procura di Milano valutare se le novità sono tali da aprire un fascicolo".
Dopo l’assoluzione Freda e Ventura non hanno più parlato? Dove sono?
"Ventura vive in Argentina, gestice dei ristoranti a Buenos Aires, pare sia ammalato. Si è sempre trincerato dietro quello che aveva detto nei processi, non ha mai detto una parola in più. Freda vive in Italia, al sud, non ha mai dato alcun segno di collaborazione. Tiene fede al suo stile di professore "nero", sempre arrogante".
Avvocato, a cosa è servito lo stragismo, chi ci ha "guadagnato", se è possibile usare questo termine?
"Uno dei pochi condannati per le stragi è Vincenzo Vinciguerra, militante dell’estrema destra in carcere per la strage di Peteano. Uso le sue parole: lo stragismo era finalizzato a destabilizzare per stabilizzare. Le stragi non puntavano a provocare colpi di Stato, ma dovevano irrigire la struttura dello Stato, dovevano impedire lo spostamento a sinistra della società favorito dal movimento degli studenti e dalla ribellione operaia. Non ci sono stati golpe, le stragi sono continuate fino al 1984 con l’Italicus. Poi non ce n’è più stato bisogno. Chi governava nel 1969, la dc, ha continuato a mantenere il potere".
12 dicembre 2009
|
il SOLE 24 ORE
per l'articolo completo vai al sito Internet
http://www.ilsole24ore.com
2009-12-12
Piazza Fontana, contestazioni e fischi verso Moratti, Podestà e Formigoni
commenti - | Condividi su: Facebook Twitter|vota su OKNOtizie|Stampa l'articoloInvia l'articolo|DiminuisciIngrandisci
12 dicembre 2009
Scontri in Piazza Fontana (Ansa)
IMMAGINI / Scontri a Piazza Fontana
COMMENTO / Sfuggire al ricatto della strage (di Miguel Gotor)
"Dai nostri archivi"
Sfuggire al ricatto della strage
Formigoni e Moratti indagati per inquinamento
Scelta la squadra per l'Expo
La Russa: serve legge di iniziativa parlamentare sulle moschee
Alta velocità: Milano-Bologna in un'ora, Frecciarossa va a bersaglio
Tensioni e contestazioni nel corso dei due cortei che oggi hanno sfilato nelle vie del centro di Milano per commemorare i 40 anni dalla strage di Piazza Fontana. Fischi e urla sono stati rivolti al sindaco Letizia Moratti, al presidente della Provincia Guido Podestá e al presidente della Regione Roberto Formigoni. In avvio di manifestazione, inoltre, i militanti dei centri sociali hanno cercato di sfondare i cordoni di polizia per entrare in piazza Fontana. Ci sono stati lanci di petardi e di fumogeni e alcune transenne sono state abbattute.
Per commemorare i 40 anni dalla strage a Milano erano partiti, nel pomeriggio, due cortei. Il primo è stato aperto da una delegazione dei familiari delle vittime e dai gonfaloni di numerose cittá, primo tra tutti quello di Milano dietro il quale ha sfilato anche il sindaco Letizia Moratti, che è stata contestata nel corso del suo intervento. Dal pubblico si sono levati numerosi fischi e una serie di "vergogna, vergogna".
Il secondo corteo è stato organizzato, invece, da Prc, Comunisti Italiani e diverse organizzazioni della sinistra e dei centri sociali. Con carri, tamburi, decine di bandiere e cartelloni, il secondo corteo ha sfilato da piazza Missori fino a Piazza Fontana, poi ha proseguito fino a piazza San Babila per dirigersi in piazza Santo Stefano. Lungo il percorso sono stati affissi dei manifesti sui muri e sono comparse scritte. Numerosi gli slogan contro il vice sindaco Riccardo De Corato e contro il fascismo, il razzismo e l'omofobia in generale.
Fino alle 17 circa non ci sono stati incidenti particolari. Ma al termine del corteo si sono registrati alcuni tentativi, da parte di un centinaio di "antagonisti" dei centri sociali, di sfondare i cordoni di polizia con tanto di lanci di fumogeni. Il loro obiettivo è di entrare nella piazza in cui si tengono le celebrazioni ufficiali.
12 dicembre 2009
Sfuggire al ricatto della strage
di Miguel Gotor
commenti - | Condividi su: Facebook Twitter|vota su OKNOtizie|Stampa l'articoloInvia l'articolo|DiminuisciIngrandisci
12 Dicembre 2009
Piazza Fontana, il salone della Banca dell'Agricoltura dopo l'attentato (Ansa)
Oggi sono quarant'anni esatti dalla strage di piazza Fontana. Molti famigliari delle vittime sono ormai morti, i sopravvissuti attendono ancora giustizia. Le istituzioni dovrebbero rispettare questo elementare diritto e fare di tutto perché esso possa avere la massima soddisfazione possibile; l'opinione pubblica dovrebbe evitare di alimentare due cortine fumogene, all'apparenza opposte, ma in realtà complementari: la cortina del qualunquismo, per cui sulla strage di piazza Fontana non sapremmo mai nulla, trattandosi dell'ennesimo mistero italiano irrisolto da accettare con fatalistica rassegnazione; quella della dietrologia, in cui i sacerdoti dell'occultismo polverizzano la verità in tante infinite personali ossessioni che finiscono per annullarsi a vicenda.
Bisogna sfuggire a questo doppio ricatto, affermando che sulla strage di piazza Fontana e in generale sulla strategia della tensione in Italia, grazie al meritorio lavoro della magistratura e di un'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta, sappiamo quanto basta per incominciare a mettere a fuoco il tema sul piano della ricerca storica.
S'impongono, però, due passaggi preliminari: bisogna tenere ben presente il nesso nazionale/internazionale e avere la piena consapevolezza che si tratta di una svolta decisiva nella storia dell'Italia repubblicana.
La prima certezza riguarda l'evidenza di una matrice neofascista che ha insanguinato l'Italia dal 1969 al 1974, ossia dalla strage di piazza Fontana a quella di Brescia. Un impasto di reducismo mussoliniano e di nuova militanza delusa dalla progressiva e faticosa parlamentarizzazione del Msi; un grumo di ossessioni razziali e anticomuniste disponibili a farsi infiltrare dai servizi italiani e stranieri e a infiltrare i gruppi anarchici in nome del proprio delirio superomista. Dalla fine del fascismo erano trascorsi 25 anni, e non c'erano solo nostalgie e revanscismi, ma anche conti da regolare con un regime democratico sempre subito, mai accettato.
Alla luce di questa consequenzialità di atti stragisti (6 in 5 anni per un totale di 50 morti) l'argomento che a Milano la bomba sia scoppiata per errore è risibile: la manovalanza che ha partecipato logisticamente all'impresa o ha materialmente portato l'ordigno poteva forse non avere la piena consapevolezza dei suoi spaventosi effetti; ma chi ha organizzato il piano era certo di volere alzare all'improvviso e a sorpresa il livello dello scontro, facendo in modo che la colpa ricadesse sugli anarchici.
La seconda certezza è che alcuni esponenti dei servizi segreti italiani hanno deliberatamente depistato le indagini affinché prendesse piede la pista anarchica e si cancellassero le prove della responsabilità neofascista. È inverosimile ritenere che agissero autonomamente, al di fuori cioé di una precisa catena gerarchica, certo selezionatissima, ma di origine politica e governativa che fu presa in contropiede dagli effetti della strage.
La terza certezza riguarda il contesto internazionale di quegli anni. Il nostro paese era un'isola giovane e democratica in un mare mediterraneo e panfascista: in Portogallo con il regime di Salazar, in Spagna con Franco, in Grecia con i colonnelli. Quest'anomalia italiana dispiaceva a quanti in Occidente ritenevano che ai gesticolanti popoli latini, per loro natura calorosi e decadenti, fosse più consona la sferza di un buon governo autoritario; la democrazia era un privilegio spettante ai popoli del nord, freddi, moderni e protestanti.
C'era un evidente interesse geopolitico, nell'ambito degli equilibri e delle logiche della guerra fredda definiti a Yalta, a tenere l'Italia destabilizzata e sotto schiaffo: prima con il terrorismo nero (dal 1969 al 1974) e poi, come un orologio svizzero, con il terrorismo rosso (dal 1976 al 1982). Sia detto con semplicità e a prezzo di qualche schematismo: per quanto riguarda i nessi e i rapporti internazionali, lo stragismo nero sta al blocco occidentale, come il terrorismo rosso sta a quello orientale. Incentivi, protezioni, garanzie, rifornimenti, lasciapassare, senza però mai perdere di vista che si è trattato di un fenomeno soprattutto endogeno, una maledetta e crudele storia italiana perché ogni popolo al fondo è padrone del suo destino.
L'ultima certezza ha le sembianze del lieto fine: la democrazia italiana, nonostante tutto, ha vinto grazie all'impegno, fra gli altri, di dirigenti politici come Aldo Moro, Enrico Berlinguer e Ugo La Malfa che hanno combattuto coraggiose battaglie dentro i loro rispettivi partiti, per contenere fermenti sovversivi e autoritari che vi erano presenti. Ma questo risultato non si sarebbe raggiunto senza la vigilanza democratica e la mobilitazione dei grandi partiti popolari e di massa. Si tratta di una lezione politica e civile da non disperdere quarant'anni dopo, che non rimargina la ferita senza giustizia, ma è il modo migliore per onorare la memoria di quelle vittime innocenti.
12 Dicembre 2009
|